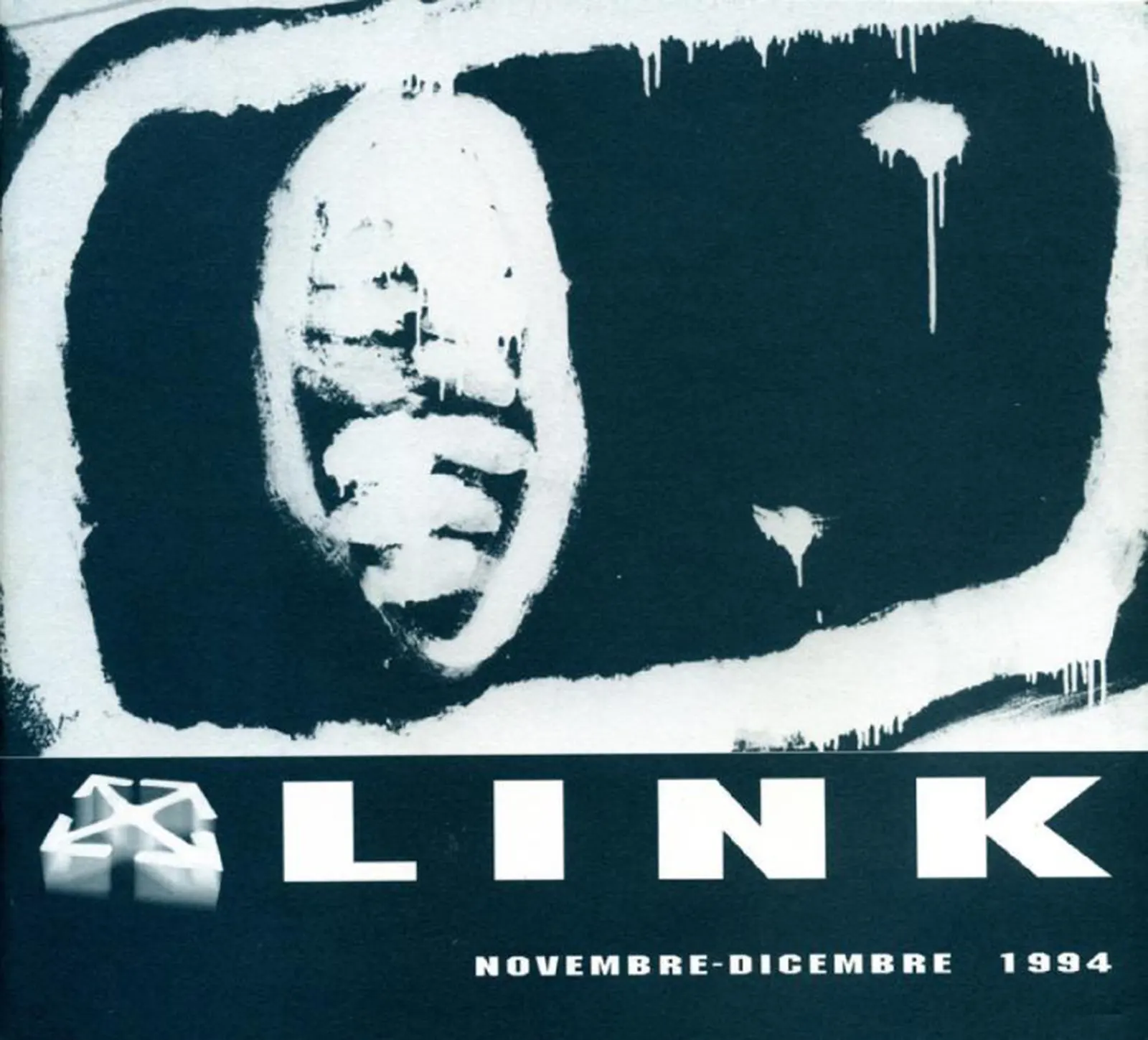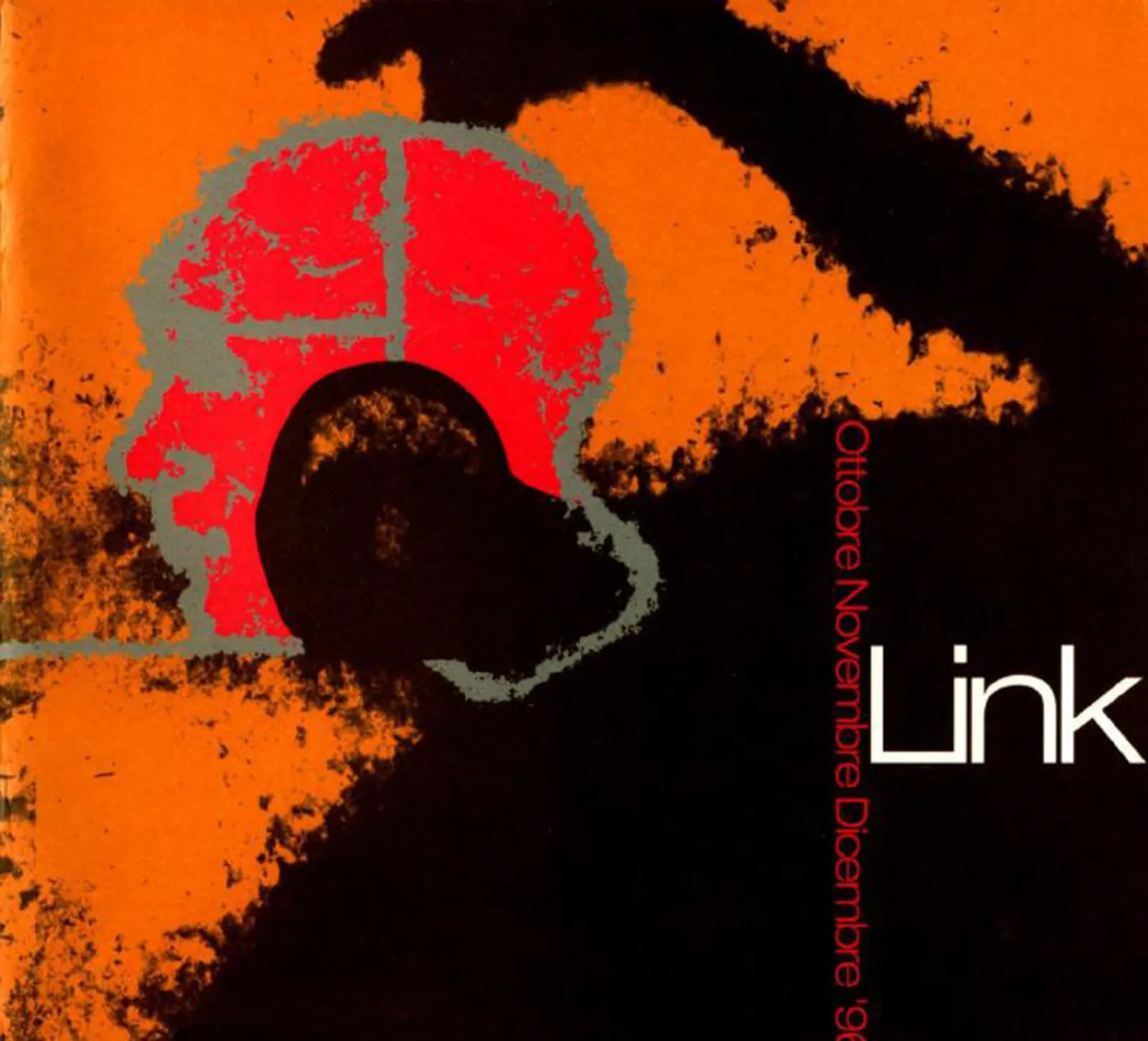marzo 2022
Valentina Valentini [da qui in poi V.V.] Inizierei col tratteggiare il passaggio dal Link Project a Xing: per quanti anni avete operato a Bologna e secondo quali linee guida?
Silvia Fanti [da qui in poi S.F.] Provo a partire dalla biforcazione di questo percorso, ovvero l’anno 2000, andando anche a ritroso. Il Link Project – nato nel ‘93-‘94 a Bologna – si trova all’apice delle sue attività in concomitanza con Bologna 2000. È un anno speciale, perché Bologna è capitale europea della cultura. Ci sono budget straordinari e c’è un’attenzione più forte da parte dell’amministrazione pubblica nel valorizzare la città, per cui si riconosce e viene incluso anche il Link. Il Link era una realtà solida, maturata nel corso di cinque, sei anni, dotata di un profilo di centro culturale indipendente, con una vocazione all’internazionalità e sensibile ai linguaggi del contemporaneo. Era un progetto multidisciplinare (termine che in quegli anni non era ancora molto diffuso e praticato, se non nel caso del Centre Pompidou) in cui le attività si muovevano in parallelo, con alcune occasioni di incrocio. Riferendoci a quegli anni non parlerei di crossmedialità né di interdisciplinarietà, ma di palinsesto. A posteriori mi chiedo, del resto, se avesse inciso la configurazione del DAMS con il suo sistema dipartimentale di Arte, Musica, Spettacolo, Comunicazione, anche se mi piace ricordare che, nel ‘98, in Francia la rivista MOUVEMENT avrebbe lanciato la questione delle arti in-disciplinate. Nel 2000 nasce Netmage festival che, nella sua prima edizione, era accompagnato dal sottotitolo Nuove Immagini tra media, arte e comunicazione, per connettere la questione dell’immagine e degli immaginari con le trasformazioni tecnologiche, digitali e di rete, che stavano emergendo in quegli anni. Sempre intorno al 2000 nasce F.I.S.Co.Festival Internazionale sullo Spettacolo Contemporaneo. La prima edizione – che non era stata ancora pensata come un progetto con un seguito, ma che sarebbe proseguita con cadenza annuale per altri dieci anni – si intitolava Corpo Sottile. L’esperienza ha dato luogo anche alla nascita di un libro1 che ha costituito un’ulteriore fase di riflessione, a posteriori, sugli eventi.

Il Link era uno spazio molto grande da gestire, articolato, ampio più di 2.000 metri quadri: uno spazio industriale, non di particolare pregio in termini di suggestioni storiche o architettoniche. Era l’ex deposito delle farmacie comunali, in cui a poco a poco ci eravamo allargati, assorbendo progressivamente particelle di spazio sino a occupare, alla fine, tutto il grande stabile di proprietà comunale, ben al di là della zona che ci era stata assegnata. Era l’epoca delle friches, degli spazi industriali dismessi riconvertiti per la cultura, delle fabbriche dell’arte, spazi nati spesso a partire da occupazioni, o da congiunture in cui convergevano gli interessi delle comunità indipendenti e delle amministrazioni che non sapevano come gestirli in attesa di possibili investimenti per una loro riconversione. Questa era una realtà italiana unica. In Svizzera c’era la Rote Fabrik, a Marsiglia La Friche, a Berlino il Tacheless… Un fenomeno che iniziava a imporsi a livello europeo nelle grandi città, mentre nasceva l’Unione Europea a Maastricht: era questa la cornice in cui noi andavamo collocandoci, percependoci in una dimensione trans-nazionale. Nacquero dunque negli anni ‘90 il Link Project a Bologna e l’Interzona a Verona: non erano centri sociali, ma factory culturali ispirate in parte a quegli spazi del nord Europa. Avrebbero poi anche influenzato alcuni centri sociali come il CPA a Firenze e, in maniera differente, pure il Brancaleone a Roma, accentuando gli aspetti culturali rispetto a quelli strettamente politici. Solo un paio di anni dopo è nato India, spazio istituzionale voluto da Mario Martone quando era il direttore del Teatro di Roma, che aveva sposato una nuova linea, maggiormente rivolta al teatro. E l’ERT a Modena si insedierà in un ex deposito delle corriere. Erano degli open space di grandi dimensioni, spazi non segmentati, capannoni e architetture che diventavano dei contenitori per attività che richiamavano molte persone e che permettevano di sperimentare idee e forme d’arte molto differenti tra loro.
Quando il Link viene fondato, nei primi anni ’90, il termine – link – non era ancora diffuso come oggi: il web muoveva i suoi primissimi passi. Significava ‘intreccio’ nella sua accezione telematica (erano gli anni del cyber-punk e delle bbs), ma anche Linke, sinistra in tedesco, e conteneva INK, Isola nel Kantiere. È divertente che, un paio d’anni dopo la sua nascita, Mediaset abbia chiamato il proprio house organ ‘Link’. Un’intuizione ante-litteram la nominazione del ‘collegamento’, e anche una pre-figurazione legata in qualche modo alle arti mediali. Il Progetto Link si scioglie dopo sei anni di attività, disseminandosi in diversi percorsi e modalità di intervento. Trattandosi di un’esperienza che era cresciuta molto, le problematiche gestionali ed economiche, stavano determinando una trasformazione del progetto che avrebbe dovuto riconfigurarsi su basi decisamente più manageriali e verticistiche. Fino a un certo punto, infatti, il Link è stato governato da un’assemblea e le attività erano decise e pianificate da gruppi di lavoro, ovvero le redazioni e i laboratori. La vocazione economica era minoritaria e in questo modo le asimmetrie si attutivano in un vivace caos, armonizzandosi in un clima di festa permanente (il riferimento è a Furio Jesi in relazione alla macchina mitologica e alla sospensione del tempo storico2). Una festa scandita non solo dal suono (i concerti, il clubbing) ma anche dalla danza, dal teatro, il cinema espanso, la video-arte, la poesia.
V.V. Fino a che punto ‘lo spazio’, che hai descritto come ‘un grande spazio’, ha influito sulle produzioni e sulla programmazione delle attività?
S. F. Lo spazio era stato rinominato con dei colori di riferimento – Sala Bianca, Sala Blu, Sala Nera – che nel tempo hanno finito un po’ per mitizzarsi, come la Sala Bianca del Link, che era lo spazio dedicato al teatro, alla danza e agli eventi più impegnativi. Oggi direi “dedicato al performativo”, ma il termine non si usava allora. Però ricordo che la nostra email era già perform@linkproject.org: già in questo, retrospettivamente, si legge la scelta di una non individualizzazione del fare all’insegna di un’area di riferimento, e l’indirizzo del contatto non era nominale. Eravamo già proiettati in avanti, se si pensa che la rinascita della performance è partitata dieci anni dopo in Italia3. Come ultima stanza, è stata aperta la Schwartz Raum, in cui si faceva – da mezzanotte in poi – il Cinema Nootropico Notturno e il Cinema Inferno. La Sala Blu era attrezzata con un impianto audio e una cabina di proiezione. Ci si faceva cinema, video, concerti e forme di sperimentazione audio-visuali. Avevamo comprato un proiettore 35 mm a Berlino – di quelli della Germania dell’Est – portato a Bologna in treno. Con questo abbiamo potuto realizzare operazioni al limite, come proiettare Satantango di Bela Tarr, otto ore con bobine da 25 minuti. C’era ovviamente un bar, grande e post-industrial, auto-costruito con i pezzi dei nastri trasportatori del magazzino farmaceutico. Di sotto, con una certa fatica, si è poi costituito il Cafè des Ignorantes con una cucina a conduzione inter-generazionale che forniva i pasti per i lavoratori, gli ospiti e il pubblico. È stato fondamentale per il nostro sostentamento in un quartiere dove c’era poco all’epoca. Abbiamo lavorato per anni in un posto grande, al freddo, con le stufe. Incontrarsi a cena era un momento di calore umano in tutti i sensi. Di fronte al Cafè, protetto da una grata tutta sbilenca, c’era un bookshop, anzi un infoshop perché non esponeva solo libri, ma vari materiali più meno autoprodotti. Le produzioni editoriali, indipendenti e non, erano frutto di scelte autonome del gruppo di lavoro che lo gestiva, e in parte erano le redazioni a fare segnalazioni aggiornate sulle aree di pertinenza. Da quel gruppo è nata in seguito una libreria vera e propria, Modo Infoshop, tuttora attiva in via Mascarella. C’erano anche le zone dedicate agli studi, ai laboratori e le sale prove, che abbiamo costruito all’inizio con i Massimo Volume, Fastilio e Splatter Pink.
Influenzati dalle esperienze del cyber-punk, il video, la grafica, il cinema sperimentale e il web rientravano in una galassia variegata composta da video-makers, designers, programmatori, singole persone o collettivi, molti dei quali provenienti dalla Pantera (il Videogiornale) o dalle occupazioni del Pratello (INK TV) e dell’Isola, che producevano immagini e comunicazione. In parte erano insediati in laboratori stabili (Opificio Ciclope e Loew), in altra misura attivi su singoli set e produzioni per la rete o le tv. L’immagine elettronica attraversava tutti gli spazi, ma senza avere quella dimensione pervasiva che ha poi assunto con la rivoluzione digitale – che cominciava solo allora a diffondersi -, gli smartphone e il web 2.0.
E c’era anche un loft, grande e appartato, in cui vivevano e operavano gli Autocostruttori. Erano dei makers, dei creativi che lavoravano con il ferro, le plastiche, il legno, i rottami di varia provenienza, realizzando sculture, arredi, gonfiabili e scenografie. Erano i ‘nipoti’ dei Mutoid (Mutoid Waste Company) che da Londra si erano trasferiti a Santarcangelo e vivevano in roulotte nel loro Campo. Tra di loro, Stephan Duve aveva iniziato a collaborare con la Socìetas Raffaello Sanzio realizzando grandi strutture meccaniche. Lo spazio delle Officine Alchemiche aveva un parcheggio che faceva da base ai camper dei ravers e dei travellers del circuito Acid e Ambient e della musica elettronica e del giro legato agli Orb (quello di Alex Paterson).
Per quanto riguarda il punto di vista organizzativo, ci eravamo ispirati a una forma simile a quella di una casa editrice o di una testata editoriale. La programmazione era un palinsesto fatto con contributi selezionati da redazioni organizzate per aree: la redazione teatrale, la redazione musicale, la redazione cinema-video, la redazione eventi (grandi o popolari). Una riunione inter-redazionale produceva, alla fine, un programma bimestrale che veniva comunicato tramite una rivista/bollettino, stampato e distribuito sia in Italia che all’estero.
In tutto questo è evidente che lo spazio ha inciso, come incide la dimensione di un oggetto stampato e la sua periodicità, in relazione ai contenuti cui dà luogo: c’è stata un’influenza reciproca tra la conformazione dello spazio e le scelte di programmazione. C’è da dire, inoltre, che a differenza di altri centri sociali nati in Italia successivamente, il Link non aveva artisti residenti in pianta stabile che avessero la priorità rispetto ad altri, e su cui incentrare la programmazione. Il Link ha presentato delle programmazioni di alto livello, all’interno di un palinsesto fittissimo. È stato un centro che ha ospitato ‘eventi’ (io oggi preferisco parlare di ‘occasioni’ per prendere distanza dalla cultura degli ‘eventifici’ di cui abbiamo sofferto successivamente in Italia). Erano occasioni per mostrare quello che non passava, non solo a Bologna ma in tutta Italia. In ambito performativo non sono state realizzate molte creazioni per il luogo, ovvero per la Sala Bianca del Link, se non in casi di produzione di progetti speciali come per Il Risveglio. Appunti per una mitologia contemporanea di Giorgio Barberio Corsetti, o Rom Stalker, Miseria Ring e Terremare di Loredana Putignani, o L’Idealista Magico e Mondo (Mondo) del Teatrino Clandestino, e Ossicine del Teatro Valdoca. Nel caso di questi ultimi si trattava di spettacoli e performance avvenute proprio all’inizio della storia del Link, quando le maglie della programmazione erano più larghe e il progetto complessivo stava ancora prendendo forma. C’era infine l’estate per chi voleva lavorare a lungo e in solitudine su nuove produzioni. Viceversa sul versante dell’ospitalità, in tempi più maturi c’è stata la serie Ombelico del Mondo di RAI Educational curata da Nanni Balestrini, di cui il Link era il set. In termini di programmazione, e a maggior ragione per il teatro e la danza, un singolo spazio non poteva venire impiegato per una sola iniziativa e restare bloccato per un tempo lungo, come sarebbe necessario per le produzioni. Era un fatto speciale che si determinava di solito quando era il Link nel suo insieme ad essere coinvolto, o eventualmente qualora ci fossero ulteriori risorse economiche esterne. Gli spazi erano multi-funzionali, non dedicati. Piuttosto, quando si offriva ospitalità, era molto chiaro agli artisti che grazie a quel contesto si potevano mutare i linguaggi della messa in scena, visto che gli spazi non erano configurati come le sale teatrali. Un’opportunità quasi unica.
Visto che il Link non aveva uno spazio attrezzato per il teatro, le idee degli artisti rimanevano rough, vale a dire che non potevano essere realizzate fino in fondo. Solo per avere un minimo parco luce ci abbiamo impiegato del tempo. Sicuramente, in area performativa, il Link è stato riconosciuto subito da artisti di varie generazioni come un luogo dove sperimentare altre forme; per questo è stato vissuto come un luogo di libertà di creazione, anche spaziale. La dimensione non era un dato indifferente, perché il luogo era veramente grande, o almeno noi lo percepivamo in questo modo, e quindi dava molte opzioni di interpretazione.
Per me, che avevo una formazione teatrale, il modello White Cube dell’ambito visivo non era un riferimento diretto: non l’avevo nè studiato nè vissuto in prima persona. A Bologna c’era la GAM Galleria d’Arte Moderna, che di fatto rimaneva un modello significativo per la sua architettura open space e i suoi volumi, e per aver ospitato la Settimana della Performance nel ’77, un tipo di spazio museale improntato al modernismo, adottato anche da singole gallerie per far risaltare le opere. Quello che proprio non ci andava bene era il teatro, con le sue connotazioni e vincoli: il palco, la prospettiva, le scenografie, la narrazione. C’era bisogno di spazi aperti, magici e crudi, ambienti spogli che mettessero a nudo lo scheletro del teatro e della danza e in cui oggetti, dispositivi, immagini e esseri viventi fossero sullo stesso piano. Ciò non toglie che per diverso tempo abbiamo usato sedie di legno da cinema – di quelle fatte a serie di quattro (ereditate da un ex cinema di Santarcangelo) – e siamo stati costretti a usare pedane per creare diversi livelli (pena: non vedere nulla, ed erano in tanti a venire). Ricordo, sempre per quanto riguarda l’uso della spazialità che, verso il 2000 apriva il Palais de Tokyo. Ci sentivamo assolutamente in sintonia con quel luogo che, più che essere un ‘modello architettonico di spazio’ (dato che si installava in un edificio già esistente, unico e quasi intoccabile, che invece fu lasciato nudo come si trovava, senza grossi interventi, con infrastrutture minime e sventramenti a vista) era un ‘modello di occupazione dello spazio’, il cui taglio era più aperto al sociale. Lì Nicolas Bourriaud e Jérôme Sans4, battezzano l’Estetica Relazionale, e lì sperimentano nuovi modelli di gestione museale.
Se la Sala Bianca ha rappresentato lo spazio dove teatro e danza si sono confrontati con una dimensione non teatrale, gli altri ambienti, molto più scuri, permettevano una vita relativamente più comoda a fenomeni musicali, audiovisivi e multimediali, che potevano concentrarsi sulla dimensione dell’ascolto, della visione (o multivisione) e del clubbing. I vari raggruppamenti che lavoravano sulla programmazione musicale, che era molto variegata, erano molteplici e vedevano una continua trasformazione partecipativa (tra gli agitatori ricordo Mauro “Boris” Borella che ha soprattutto seguito tenacemente tutto il percorso dei linguaggi ritmici innovativi). Ognuno di questi artisti e gruppi che lavoravano sul suono dava un appuntamento con cadenza annuale, realizzando convention o festival. Nei momenti di maggiore attivazione, tutto l’edificio, tra piano terra e sotterranei, produceva un flusso di circolazione abbastanza singolare, consentendo di scivolare da un’atmosfera e da un ambiente all’altro, tramite passaggi che si riducevano spesso a stretti pertugi e scalette, come a far compiere dei salti improvvisi tra aree immaginarie ed estetiche che corrispondevano spesso alle geografie sonore del mondo dell’elettronica di quegli anni. Senza mai raggiungere dimensioni realmente massificate, si è comunque raggiunto un limite di utilizzabilità. (Nessuno si è mai fatto male).
È proprio nel contesto di quei momenti più saturi che si sono poi compiuti alcuni esperimenti che hanno dato vita a LINKA, una specie di redazione delle Arti Visive (ne facevano parte anche Luca Vitone e Andrea Lissoni) che ha inventato prima Incursioni, poi Hops! e alla fine i Killout. Erano dei formati che si avvicinavano all’idea di festival, dove, più che lo spazio, a determinare le scelte e le soluzioni adattative era il metabolismo delle attività del Link nel loro insieme, come in una sorta di intarsio antropo-scenico.
V.V. Il sostentamento delle attività del Link proveniva interamente dalla vostra capacità di gestione? Avevate anche contributi da istituzioni pubbliche e private?
S.F. Link Project è stata un’occupazione di fatto di uno spazio che avrebbe dovuto essere dato in convenzione a un gruppo di una cinquantina di persone (eravamo tra i 20 e i 30 anni, con qualche eccezione) che si era costituito appositamente in associazione. Quasi tutti i soggetti venivano dalle occupazioni della città: dall’Isola nel Kantiere (che è attualmente il retro del Teatro Arena del Sole,) alle case occupate di Via del Pratello e Via Avesella, ai collettivi del DAMS (Damsterdamned, Videogiornale, Laboratorio di Musica & Immagine…) e dell’università: tutte esperienze di autogestione. Dopo gli sgomberi, nel tentativo di ricucire un rapporto con questi movimenti sottoculturali, il Comune aveva promesso uno spazio a questo nuovo soggetto costituente; ma le cose si sono a tal punto dilungate, che a un certo momento si è entrati e lo si è aperto, in un banale martedì invernale. Questa azione è stata tollerata. La nostra realtà, tuttavia, non è mai stata valorizzata da un punto di vista istituzionale. Si è ottenuto un atteggiamento di laissez faire, che era già qualcosa (col senno di poi, qualcuno di noi sospetta che senza quella piccola forzatura, quel project non si sarebbe mai avviato). L’unico intervento diretto che ricordo era stato uno stage con dei giovani bio-architetti guidati da un architetto del Comune, considerato un visionario per quei tempi, che li aveva messi a costruire il muro di divisione dello spazio assegnato in paglia e fango, ben presto aperto da un varco. Solo la redazione teatro aveva provato a interloquire con il Comune di Bologna, chiedendo un contributo alle attività, che era stato dato e che probabilmente doveva essere di qualche milione di lire. Tutto il resto si è sempre mosso, invece, in una dimensione di autonomia e di autosufficienza tramite sottoscrizioni.

V.V. All’interno di queste dinamiche, quali sono state le alleanze maggiormente proficue?
S. F. Ovviamente alleanze culturali, più che politico-istituzionali. Sono stati coinvolti tanti soggetti, in primis gli artisti. Ogni settore aveva il suo modo e le sue dinamiche. Ragionando sul settore musicale, le etichette stesse, le ‘label’, sono state dei partner, degli alleati. Oltre a ciò vi era il rapporto con i singoli artisti che passavano dal Link. Con alcune etichette c’era un rapporto continuativo. E tra queste ci sono stati dei punti di riferimento che si sono affermati nel tempo di pari passo con il Link5. Per quanto riguarda le altre aree ci sono state delle istituzioni, come ad esempio TTVV Riccione con cui abbiamo collaborato. La relazione con loro si era saldato anche per via di RIFRAZIONI, il catalogo di distribuzione di video-arte che avevano creato Daniele Gasparinetti e Rainer Bumke (prima di entrare in Studio Azzurro) che era collegato al collettivo Damsterdamned e alla cooperativa A LATO, e stava nella storica Via Guerrazzi (sede del DAMS e dei collettivi del DAMS occupato). Lì abbiamo anche catalogato parte dell’archivio video di TTVV. Il rapporto di collaborazione era proseguito nella transizione verso il Link. Così come quello con tanti singoli intellettuali. Ci sono stati anche i media: ricordo che Il Manifesto e Alias specialmente, ci davano ascolto. Avevano capito che eravamo un interlocutore rispetto ai loro interessi. Andando a memoria, c’erano Ninì Candalino e Roberto Silvestri per la scena del video e cinema indipendente; Radio 2 Ultrasuoni e Radio 3, Battiti seguivano invece i diversi aspetti della programmazione musicale; viceversa Gianni Manzella con riferimento al teatro è stato supportato dal Link che a sua volta ha prodotto i primi numeri della rivista Art’o_cultura e politica delle arti sceniche, e che infatti riproponeva il medesimo formato quadrato della rivista del Link. Mandavamo l’house organ anche a tutti questi interlocutori potenziali, e la rivista era veramente l’oggetto attraverso cui si comunicava. Il fatto di aver deciso di far approdare su carta i nostri pensieri e orientamenti, oltre che un calendario bimestrale, e di spedirli fisicamente a quelle due o trecento persone in Italia e anche all’estero – che per noi erano dei riferimenti – ha contribuito a rafforzare in maniera diretta e indiretta l’operato del Link. Magari alcune delle persone che raggiungevamo con quel mezzo avevano messo piede al Link poche volte, ma hanno supportato il progetto culturale da lontano. Come ho detto, il Link ha ospitato una serie tv della RAI – venti puntate di L’Ombelico del Mondo (forse era il ’99 o il 2000) – che, immaginata da Nanni Balestrini e Paolo Fabbri, voleva rovesciare il pregiudizio legato alla poesia come cosa noiosa. Tra i nomi ricordo almeno Edoardo Sanguineti, Achille Bonito Oliva, Luciano Berio… Un contatto diretto che, negli anni in cui si stava sviluppando la produzione video indipendente e si attivavano le tv private, è stato uno dei trait d’union per far transitare alcune autorialità italiane legate alla danza (penso ad Andreas Pichler, Anna De Manincor, Lino Greco). Era il tempo della video-danza, con Elisa Vaccarino che commissionava per i canali tematici della prima RAI satellitare…
Con il Dipartimento di Spettacolo dell’università di Bologna c’è stata una fase di collaborazione, in particolar modo con Cristina Valenti, che si è sempre professata libera da ogni forma di costrizione e aveva ritrovato in alcune nostre modalità qualcosa cui si sentiva vicina. Inizialmente aveva proposto un evento-reading con Judith Malina/Living Theatre, a cui avevamo avvicinato Alberto Masala (anche lui stava al Link): una cosa molto leggera, più legata alla poesia. Poi abbiamo intessuto un rapporto più forte di co-progettazione per realizzare una nuova produzione con Giorgio Barberio Corsetti a Bologna, coinvolgendo le varie competenze del Link e attraversandone lo spazio nel suo complesso. L’avevamo presentata assieme all’università, che iniziava a fare dei programmi pubblici per la città, connettendosi con vari luoghi e organizzazioni. Più che sull’insegnamento universitario, che era impermeabile a situazioni come la nostra, quella con la Valenti era un’alleanza orientata a tutto ciò che dal vivo poteva servire per costruire un percorso diretto di conoscenze agli studenti (e non solo). È sempre stato importante guardare fuori anche a livello internazionale. In quel caso spesso le alleanze erano indirette, mediate e captate. Abbiamo fatto vedere delle vere rarità, prese da ARTE e ZDF, la TV tedesca, senza chiedere permessi ovviamente. Ce le mandavano altri studenti tedeschi e francesi: facevamo vedere in anteprima cose che non passavano né nei cinema né nelle TV italiane. Poi c’era, nei limiti di spazio, una pratica di ospitalità. Tra gli altri AngelicA Festival Internazionale di Musica ha avuto sede da noi per diversi anni. E anche la casa editrice di Luca Sossella. Erano veramente tanti i livelli su cui si dipanavano queste relazioni e reti. E il tutto si intrecciava in un unicum parecchio complesso. Poi l’alleanza più forte e motivata era quella con i frequentatori del Link, che erano veramente tanti, una moltitudine.
V.V. Cosa è accaduto dopo la conclusione del Link Project?
S. F. Link Project è stato uno spazio, ed è stato un progetto collettivo. Chiuso il Link Project come entità, è rimasto il luogo attivo nella stessa sede di Via Fioravanti ancora per tre anni, gestito da una nuova entità, Link Associated, che si è evoluto in un’altra direzione per poi spostarsi infine in una nuova sede. Esiste tuttora, rifondato più volte all’interno all’ex macello del CAB di Bologna in Via Fantoni.
Dopo la conclusione del progetto Link nel 2001, abbiamo trascorso un anno di puro nomadismo. Una dimensione ricercata, non subita, di cui sentivamo il bisogno. Si è intervenuti in città, in diversi luoghi e collocazioni, costruendo da zero dei progetti speciali e contestualmente curandoli. Ogni progetto veniva costruito ad hoc e doveva essere in qualche modo unico e autonomo, anche dal punto di vista finanziario. Dopo due anni circa, c’è stata la voglia, la necessità di darsi una base operativa (al tempo, va detto, non avevamo neanche degli uffici dove lavorare e l’archivio era inscatolato in depositi). È iniziata a essere chiara la fisionomia di questo luogo di cui sentivamo il bisogno e l’articolazione delle attività di Xing, che era la nuova entità nata da alcuni dei fondatori del Link, tra cui me, Daniele Gasparinetti, Andrea Lissoni, Paolo Liaci, e poi da Milano Giovanna Amadasi, Federica Rossi, Luca Vitone, e da Parigi Giovanna Zapperi.
Abbiamo avuto voglia di insediarci in un luogo che abbiamo cercato sul mercato e che abbiamo preso in affitto: Raum. Un progetto su una scala volutamente piccola, di gestione flessibile e snella, in un luogo dove fare palestra, condividere esperienze di ricerca e creazione artistica da offrire agli artisti. Questo è accaduto dopo esserci focalizzati su eventi più grandi (i festival Netmage e F.I.S.Co.), eventi ricorrenti una volta all’anno che mostravano lo stato delle arti, in un tempo ridotto e in spazi della città potenzialmente significativi per la collocazione e per il valore trasformativo sul territorio. Le due dimensioni correvano in parallelo e si sviluppavano integrandosi: tra Raum, che è uno spazio di 200 mq in un ex convento del 1500 nel centro della città, e poi questi momenti di festival e di chiamata a raccolta.

Xing continua tutt’oggi ad essere produttore di formati e prototipi che sono stati testati e letteralmente messi in forma. Forse questo interesse per la connotazione nominale dei formati è un lascito dell’impostazione editoriale con cui siamo cresciuti. Dal 2003 Xing ha messo in atto: Accademie Eventuali, Archivi Privati, Art Fall, Camping, Desco Music, Dialogico, Extra-Raum, F.I.S.Co., Flora, Hypnomachia, Italian Landscapes, Italian Live Media, Live Arts Week, Living Room, Microclima, Netmage, Oplà. Performing Activities, Phonorama, Prepared Room, Raum, Redirect rinvii curatoriali, Sant’Andrea degli amplificatori, Shift, Sporting, W, Working Room, Worklab, Xong. Attualmente stiamo lavorando su degli Holes. Tutte queste labels sono i nomi di ciò che consideriamo dei formati.
L’interesse rivolto all’invenzione del formato nasce sempre dalla condivisione di uno spazio, di un tempo, di un momento estetico e di una convocazione. In essi sono compresenti un artista e un pubblico (dico pubblico per semplificare, perché anche su questo termine e su questa posizione altrettanto centrale nelle live arts, abbiamo fatto un percorso: spettatore, interlocutore, ricercatore, testimone, compagno, coabitante…). Come organizzazione c’è sempre stata coscienza di questo circumnavigare un accadimento dal vivo, di ‘accenderlo’ per poi continuare a osservarlo nelle sue evoluzioni. Senza irrigidirsi. È importante poi distillare dei caratteri di avanzamento a partire dalla auto-percezione del sistema creato. Così è stato per il Link e per Xing, che nasce come puntualizzazione e perfezionamento di alcuni elementi: le figure degli operatori, i progetti, le collocazioni e le linee curatoriali. Infine, una professionalizzazione. Un’auto-formazione sul campo, non accademica.
V.V. In questi anni avete avuto un pubblico non solo bolognese. Quali strategie per il coinvolgimento degli spettatori?
S. F. Ormai sono trentacinque anni che lavoriamo, ci sono state delle epoche, delle generazioni, dei modi e interessi diversi: non si può fare un discorso unico. Il Link era un esempio molto ampio di confluenza di tante diversità che non chiamerei comunità. Si trattava di una compagine che aveva in parte a che fare con l’università, in parte con molte correnti sottoculturali e vicine alle post avanguardie e in parte con una intellighenzia più matura. Forse era la somma di tante tribù. Ci si incontrava in questo luogo, perché era una sorta di calamita. Lo era anche a livello urbanistico per la città: il Link stava esattamente nell’area che, dopo l’abbattimento, è diventata la nuova sede del Comune di Bologna, dietro la stazione, fuori le mura, quindi si andava oltre le porte della città medievale. Un’inversione di rotta molto chiara: si andava fuori. La comunicazione avveniva tramite un buon uso dei media, che all’epoca aveva il fax come strumento fondamentale. L’ufficio stampa portava le foto a mano nelle redazioni dei giornali dove c’erano solo i custodi, quando finivano le serate alle 3, 4 di notte… Quando si è lasciato quel grande terreno di confluenza, e la stanzialità, si è cercato di trovare il richiamo giusto, più preciso, per tribù che si spostavano in zone incognite. Era la stagione post-rave, che nasceva nelle periferie, nei boschi, negli spazi industriali abbandonati.
Abbiamo comunicato con coscienza con il pubblico generalista nel momento in cui siamo entrati nelle roccaforti della città. È il caso di Netmage, che nelle ultime edizioni è stato realizzato nella piazza centrale di Bologna, a Palazzo Re Enzo, durante Arte Fiera, in un momento in cui Bologna diventava uno snodo, un punto d’incontro nazionale. Ci siamo confrontati con il bioritmo e il linguaggio di una città nel suo senso più allargato. In quel caso abbiamo iniziato veramente a confrontarci con un pubblico generalista, conoscevamo solo parzialmente le facce di chi ci seguiva, mentre nella dimensione più ridotta di Raum abbiamo cominciato a costruire delle comunità estetiche: quanti hanno seguito le proposte culturali di Xing non erano certamente dei curiosi casuali o degli annoiati. C’era una fetta importante di artisti. È stato un percorso di crescita condiviso tra gli artisti invitati e chi ha seguito le nostre proposte e ne è stato influenzato. Certo, tra gli alti e bassi della composizione sociale di Bologna soprattutto nel momento in cui il DAMS ha perso lo smalto e la centralità. Sicuramente l’arretramento dell’università, incastrata in un moderato conservatorismo e il mancato ricambio del corpo docenti, ha influito su tutto il tessuto della cultura sperimentale. Raum è stato per oltre quindici anni un luogo di punta per l’innovazione, in cui sono circolate idee: grazie a ciò è stato seguito da un pubblico giovane più attento, trasversale. Hanno quindi fatto palestra artisti che hanno mantenuto questa predisposizione. È un fatto che sia stato recepito e riconosciuto più dal mondo istituzionale delle arti visive e della musica, che del teatro.
A Raum non si usano i codici del teatro né quelli dell’arte. È un luogo da frequentare, da seguire, su cui sintonizzarsi (ed avviene immediatamente anche quando è inattivo, perché conserva un esprit). Non c’è mai stato un pubblico che arriva, paga un biglietto (anche perché non usiamo biglietti e tuttora continuiamo ad apporre un timbro a chi entra) e pretende qualcosa. Abbiamo anche ragionato con alcuni artisti sul concetto del frequentare, to attend, che non implica solo un appuntamento in cui ci si sposta per andare a vedere qualcosa per quaranta minuti, ma significa avere un punto di riferimento e una continuità, un punto di incontro che non ruota attorno alla funzionalità dello spettacolo, e in cui il prima e il dopo sono ugualmente importanti. Un tempo omogeneo, non più scandito o mediato dal bancone del bar: anche questo non è un dettaglio, abbiamo messo un frigorifero autogestito, ognuno si serve e paga quello che vuole. Abbiamo evitato barriere e convenzioni posturali, con l’idea che fosse facile gestirsi liberamente da sé, viste le dimensioni e i numeri ridotti. Man mano che i formati si sono consolidati, la capienza fisica di 50/70 persone di Raum è diventata magicamente il numero perfetto per quelle attività. Lo standard effettivo e soddisfacente per tutti erano 40 persone: 40 è una cifra perfetta (aurea?), quella che garantisce un bilanciamento giusto tra le dimensioni del luogo, il tipo di esperimento che viene condiviso, la posizione dello spettatore e quella dell’artista. La questione del pubblico mi interessa tantissimo: a questo proposito c’è una lunga storia di esperimenti che abbiamo fatto, con una cronologia del mutamento di modelli e rapporti spettatoriali. Con l’ultima edizione di Live Arts Week, la decima, realizzata a giugno 2021 in un campo aperto sulle sponde del Lungo Reno, abbiamo fatto esplodere la “categoria di spazio” disseminandoci in una zona di un paio di chilometri, senza un centro focale. Non sappiamo chi sia venuto, non sappiamo quanti, ma abbiamo visto che ritornavano. E questa è la cosa che più gratifica, perché su questa scelta reciproca, non misurata, siamo sicuri che chi c’è, c’è perché ha voglia di esserci.
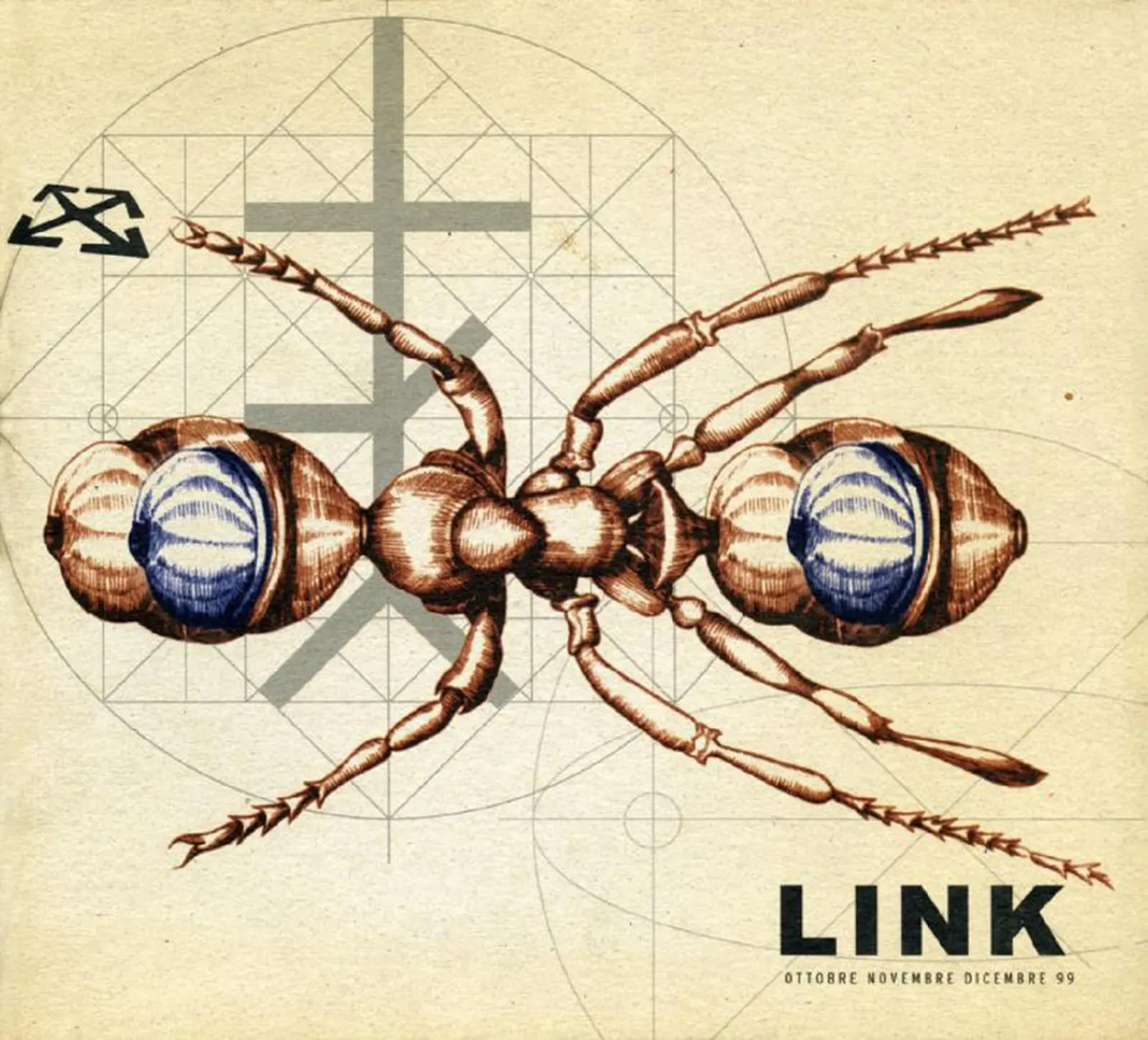
V.V. Quali rassegne, spettacoli, concerti, mostre hanno lasciato un segno?
S. F. In trentacinque anni abbiamo ospitato migliaia di artisti. Facciamo un esempio per decennio.
Fondativo per il Link Project è stato L’occhio Belva di Motus, 18 gennaio ‘95: abbiamo svuotato la Sala Bianca del Link piena di scaffali per medicinali e dipinto di bianco lo spazio, perché lo spettacolo doveva avvenire in questo ambiente de-localizzato. Lo voglio ricordare qui – aldilà del fatto che L’occhio Belva è stato un modello per il teatro italiano – in funzione delle relazioni e delle energie che si sono attivate per l’occasione. Ci siamo messi insieme: le persone di Link Project e le persone di Motus hanno unito le loro forze e hanno fondato un luogo per il teatro, che è stato abitato da molti altri artisti e lavori per i sette anni successivi.
Un altro momento importante in termini di mind frame e quindi di evoluzione della mia ulteriore consapevolezza sulle live arts, è stato quando abbiamo invitato a Corpo Sottile due compagnie che per me erano (e sono ancora) tra le più innovative, le più significative dell’arte performativa in Italia, cioè Kinkaleri e MK. Stiamo parlando del 2000 o 2001. Assieme a loro abbiamo invitato Xavier Le Roy, Jérôme Bel e Myriam Gourfink. Questa congiunzione di sperimentatori di linguaggi ha rappresentato un cambio di paradigma, non solo per noi, ma per l’Italia. Si è trattato di una cesura, un momento importante, di cui vedo i riflessi ancora oggi.
Poi, passando al 2012, arrivo alla prima edizione di Live Arts Week: è il momento in cui quanto accaduto nell’ambito delle arti elettroniche e ciò che avevamo esperito con i new media, anche in rapporto alla liveness, si fonde con il teatro e la danza, mutandosi in nuove forme di live arts. Ricordo il progetto con Marino Formenti, Nowhere, dedicato a Cage: un negozio vuoto, affittato in città, in cui un pianista ha vissuto, dormito, suonato, per dodici giorni consecutivi, lasciando le porte aperte a chiunque volesse andare a immergersi in questo ambiente. E quindi il nuovo paradigma è il suono come ambiente, la performance in cui l’artista non è l’artefice, ma colui che condivide spazio, tempo e anche una maniera d’essere. Ricordo con grandissima felicità la possibilità di sdraiarsi sotto il pianoforte a coda mentre un musicista di grande levatura suona Morton Feldman, e quindi la possibilità di stare dentro la musica, dentro l’opera. In contemporanea, sempre negli stessi giorni, accadeva Hotel Palace di Yves Noel Genod, un artista francese, un outsider, che aveva preso in ostaggio l’Hotel Palace (che noi utilizzavamo abitualmente per l’ospitalità degli artisti). È un albergo decisamente fuori moda, un quattro stelle in decadenza, senza le televisioni, con i bagni obsoleti e con un grande salone, un po’ alla Marguerite Duras: ambienti sospesi tra le epoche, un po’ invecchiati. Yves Noel Genod aveva portato alcuni degli artisti con cui collaborava e aveva dato appuntamento a chiunque lo volesse seguire dalla Francia a venire a stare a Bologna, in quell’hotel, in quei giorni. Mi ricordo che era venuto un mecenate, un signore che ogni tanto comprava bottiglie di champagne e le faceva girare. E aveva seguito la realizzazione di un lavoro che veniva provato e eseguito negli spazi comuni di questo hotel, mescolandosi con l’attività ordinaria di un albergo, per cui gli ospiti si trovavano coinvolti nelle prove nei saloni del piano terra, in cui c’era Yves Noel Genod che dirigeva questa troupe di squilibrati. Gli avevamo fatto fare un giro nei magazzini del Teatro Comunale di Bologna dove avevano scelto dei costumi che sembravano funzionare. Poi erano stati coinvolti a Bologna due fratelli autistici con i loro due genitori psichiatri sperimentali. Un’amica comune, che traduceva dall’italiano al francese, si era portata i figli, anche loro finiti nel cast assieme a non sappiamo quante altre persone incrociate da Yves Noel per strada. Era un caos dove non si capiva chi fosse chi, e il pubblico era stato invitato la sera per assistere a questi episodi, in una situazione che era poetica per sua natura. Alla fine è intervenuta pure la polizia, perché qualcuno andava in giro nudo con il cappotto e c’era chi pomiciava, senza far distinzione di genere. C’erano delle maestre in gita scolastica, scandalizzate, che ci hanno denunciato. È stata una situazione che ha colpito tante persone, non solo noi, una forma di neo-happening, perché di fatto questo era, con delle intromissioni. Il piano del reale e della finzione erano totalmente confusi.
L’ultimo segno che mi viene in mente è quello lasciato da Maria Hassabi, e in questo caso si tratta di una pratica. Abbiamo presentato PREMIERE a MAMbo e STAGED(?) alla EX GAM Galleria d’Arte Moderna, in due diverse edizioni di Live Arts Week. Quello di Hassabi è un lavoro coreografico sull’immagine, una forma di scultura espansa, fatta di micro-accadimenti muscolari, di passaggi e spostamenti minimi, che alterano la percezione del tempo e dello spazio. I corpi (abbigliati) sono delle masse che ruotano attorno a più assi, tra intensità e rilassamento. È meditativo seguire la contorsione di queste forme umane, le negoziazioni millimetriche dei corpi dei performer con lo spazio. Sono performance che si dipanano in lunghe estensioni di tempo, che danno un altro passo all’attenzione, la amplificano. Il risultato è allo stesso tempo figurativo e astratto. Negli anni successivi al nostro incontro, Hassabi ha lavorato molto in ambito museale, ma trovo che le sue azioni siano più coraggiosamente testarde quando questo regime si mescola ad altre attività, nell’indifferenza di altri accadimenti, in ambienti meno sacrali.
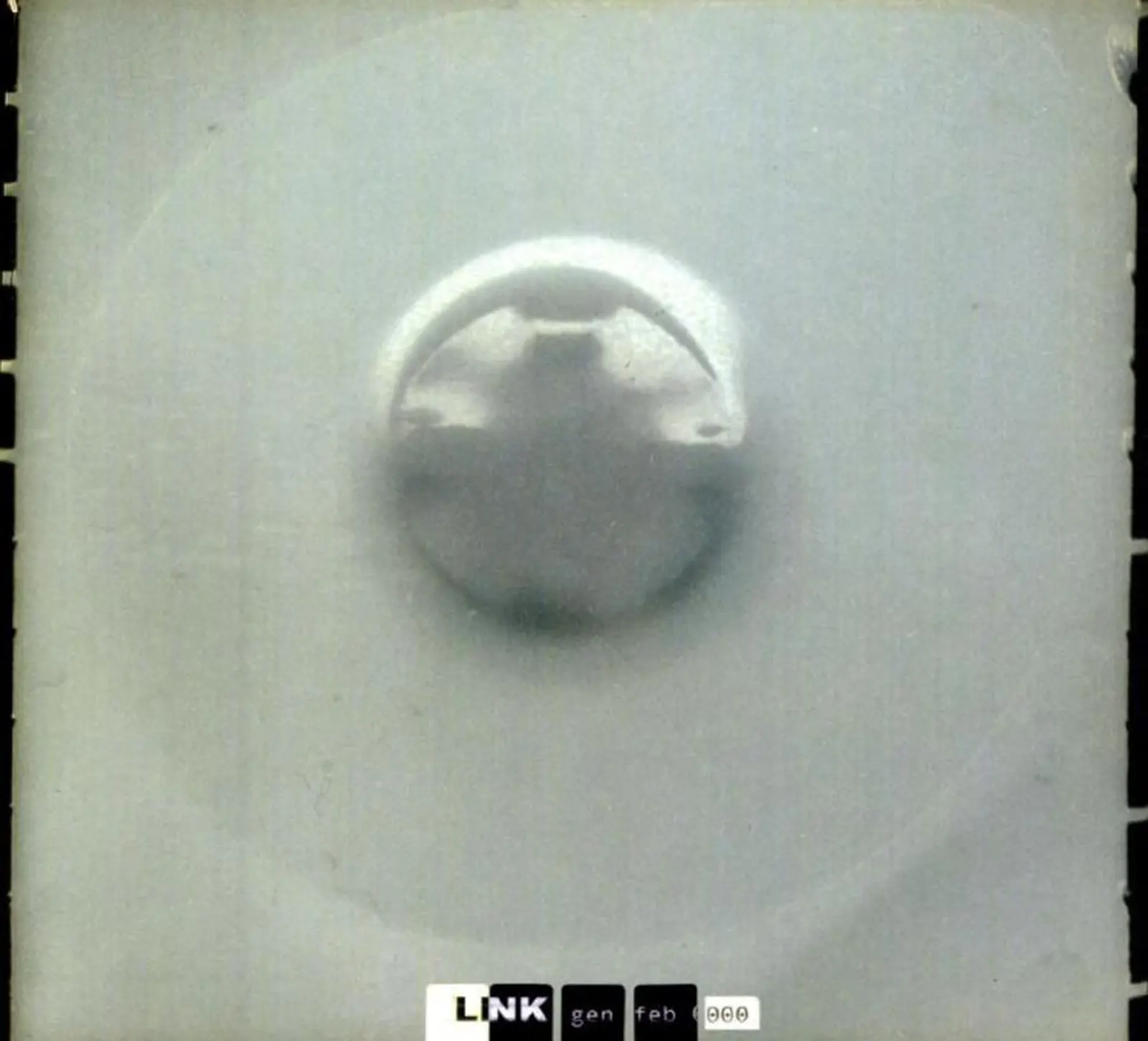
V.V. Dopo queste esperienze pensi di poter mettere ulteriormente in discussione il concetto di “luogo”?
S. F. Adesso abbiamo deciso di sperimentare dei buchi, gli Holes, occupando e attivando luoghi non istituzionali come ridefinizione temporanea di uno spazio pubblico; ospiteremo degli Istituti di Alta Formazione nomadici tra cui un Istituto del Riposo. Saranno dei momenti di riflessione, studio, produzione e trasferimento di pratiche innovative. Poi proseguiremo con le produzioni sonore in vinile di personalità del mondo performativo per Xong Collection, dischi d’artista. Ovviamente è un passaggio.
- Silvia Fanti (a cura di), Corpo Sottile. Uno sguardo sulla nuova coreografia europea. Jérôme Bel, Xavier Le Roy, Myriam Gourfink, Kinkaleri, MK, Ubulibri, Milano 2002. ↩
- Cfr. fra le tante pubblicazioni di Furio Jesi, Il tempo della festa, Nottetempo, Milano 2013. ↩
- Il Premio Internazionale della Performance promosso da Fabio Cavallucci è del 2005 e da qui si sviluppa una rinnovata attenzione alla performance; Hops! festival di visual e performing arts nasce al Link nel 2000 ed ha un’iterazione nel 2001, seguita da un convegno tematico ad Arte Fiera nel 2002. ↩
- Di Nicolas Bourriaud, tradotti in italiano ricordiamo: Estetica relazionale (1998); Forme di vita (1999); Postproduction (2002); Il radicante (2009); L’exforma (2015). Jérôme Sans, critico d’arte, ha fondato insieme a Nicolas Bourriaud nel 2000 il centro d’arte contemporanea di Parigi, Palais de Tokyo che dirigono fino al 2006. ↩
- Qui si apre un capitolo molto complesso e articolato sul mondo musicale del Link che rimando ad altre occasioni e testimonianze dirette di altri. Mauro Borella, che aveva impiantato la Huge, mi scandisce velocemente il quadro sulle label che riporto: “Nel settore IDM (Intelligent Dance Music) c’era la Rephlex record e la Warp (di Richard D. James – Aphex Twin) di cui facemmo esibire molti artisti. Per quanto riguarda altri generi, il rapporto continuativo più che con delle etichette era con singoli artisti area post/avanti rock come Unwound, Shellac, Labradford etc. Poi c’è stata tutta la scena noise della Mego austriaca, l’elettronica minimalista della finlandese Sähkö, l’elettronica sperimentale e la minimal techno della Subrosa belga e della Mille Plateaux di Francoforte. Ma anche l’easy listening di Notte Vidal con artisti come Stereo Total, Plastic People, e tanti della Irma records come i Montefiori Cocktail. Le più fedeli su tutte son state le etichette di diversa nazionalità distribuite della Final Frontier di Marco Passarani e Andrea Benedetti: techno ed electro di insuperata qualità. Su tutte la nord americana UR Underground Resistance di Detroit. Altre label centrali per la programmazione musicale più ibrida che seguiva al Link Enrico Croci erano la Interscope, Novamute, Wax Trax!, Touch and Go, e Matador.” ↩