Una robusta tradizione ermeneutica insiste nel ritenere che – nel rapporto tra gli esseri umani e le opere d’arte – ci siano aspetti che non sono suscettibili di spiegazioni razionali del tipo, per esempio di quelle che valgono per i processi fisici, le sezioni geologiche, i sintomi delle malattie. Questo carattere particolare delle opere artistiche sarebbe diventato ancora più evidente con l’emergere dell’astrattismo e – per quello che riguarda il teatro – col progressivo abbandono del testo e la rinuncia programmatica a rappresentare qualcosa. In questo lavoro, dopo avere discusso i limiti degli strumenti psicoanalitici e semiologici nell’affrontare questo problema, provo a mostrare quale possa essere l’utilità delle scienze cognitive e delle odierne teorie della comunicazione umana, analizzando un caso specifico di “messaggi senza significati”: quello della musica.
Prologo 1 – Le domande
«Si possono comprendere gli spettacoli?»
Nel 2004, nel suo studio sull’estetica della performance (Fisher-Lichte, 2016, p. 267), Erika Fisher-Lichte ha sollevato esplicitamente una domanda del genere, proprio al culmine di una riflessione sul significato e sugli effetti del teatro contemporaneo. La domanda – così esplicita e diretta – è quasi imbarazzante, perché se la risposta fosse radicalmente negativa avremmo allora che gli spettatori (ma anche l’autore, gli attori, tutti gli astanti) sarebbero convenuti nel luogo dello spettacolo per partecipare a qualcosa che – per sua natura – non può essere afferrato, fatto proprio, penetrato, fruito pienamente.

Che molti aspetti dell’arte contemporanea non siamo intellegibili è per altro un luogo comune, nel discorso e nella convinzione ordinaria di molti non specialisti. Più strano potrebbe sembrare il fatto che un interrogativo del genere venga posto da una studiosa del rango della Fisher-Lichte, impegnata a ragionare sulle arti teatrali da più di mezzo secolo. Ancora più difficile potrebbe sembrare il fatto di dover riconoscere – con Fisher-Lichte – che la risposta alla domanda «si possono comprendere gli spettacoli?» è necessariamente negativa: gli spettacoli sono in gran parte incomprensibili, perché gli aspetti non legati alla rappresentazione di qualcosa, ma alla pura “presenza” (cioè alla mera percezione, o all’esperienza estetica che produce effetti sul corpo, senza arrivare all’intelletto) non sono decodificabili, cioè non sono esprimibili mediante un linguaggio (Fisher-Lichte, 2016, pp. 276-277).
Una conclusione del genere – è bene notarlo – presuppone che “comprendere” qualcosa (uno stato, un evento o un processo) equivalga a “riuscire ad esprimerlo in una forma proposizionale”; ed è dubbio, in effetti, che un’operazione del genere riesca, quando la cosa da comprendere riguarda una sensazione, un affetto, l’immersione in una certa atmosfera o una specifica condizione del corpo; percezioni che potrebbero non raggiungere il livello della consapevolezza e dell’elaborazione cosciente.
Ma un dubbio rimane: possiamo ancora ammettere, per quanto noi ne sappiamo del corpo e della mente, che la comprensione sia qualcosa che appartiene soltanto all’intelletto, e che le attività cognitive si arrestino, sulla soglia dell’indicibile?1
Anche Fisher-Lichte è portata a riconoscere che le sensazioni e le affezioni emergenti da processi puramente percettivi (quando sono almeno avvertite, malgrado non siano esprimibili in una forma linguistica) devono essere considerate come stati della coscienza che hanno significati (Fisher-Lichte, 2016, p. 245). Ma allora, anche ammesso che quegli stati non rinviino a nulla di altro (tranne il fatto di presentarsi come tali), se essi possiedano un significato (come Fisher-Lichte ammette) ne consegue che il loro dominio costituisce comunque un campo semantico.
Di più, Fisher-Lichte è incline ad ammettere che anche le percezioni inconsce siano in grado di influenzare le nostre reazioni (Fisher-Lichte, 2016, p. 244); si apre allora la possibilità di inferirne il ruolo, dall’analisi dei comportamenti che esse contribuiscono a determinare. In un quadro del genere, la “comprensione” di uno spettacolo (nel senso che cercheremo più avanti di abbozzare) potrebbe essere assolutamente possibile, ed essere accolta anche a livello teorico (sempre ammesso che si diano ipotesi esplicative adeguate, circa i processi – consci o inconsci – che determinano particolari reazioni).
Siamo allora in grado di delimitare il problema che vogliamo affrontare: quali attività cognitive sono all’opera, nelle relazioni che si instaurano in un evento teatrale, tra coloro che lo hanno concepito, allestito e promosso, e tutti quelli che sono lì convenuti? Possiamo immaginare che le relazioni che si istaurano in un evento del genere siano analizzabili con gli stessi strumenti che si utilizzano – più in generale – nello studio della comunicazione tra gli esseri umani? E che, dunque, le attività cognitive che sono in gioco nella “comprensione di uno spettacolo” sono quelle – né più né meno – che sono all’opera quando agiamo comunicativamente con un certo interlocutore? E che sono all’opera quando costui reagisce a sua volta, cambiando il suo stato e – magari – comunicando a sua volta qualcosa?
In un certo senso, è addirittura ovvio che sia così: il dominio della comunicazione è talmente ampio, soprattutto nella nostra specie, da far ritenere quasi impossibile che un’attività svolta da esseri umani, che implica una interazione tra loro, non ricada in quel preciso dominio. Tuttavia – negli studi sul teatro, sulle performance e sulle altre arti dello spettacolo – i risultati e gli avanzamenti acquisiti negli ultimi trent’anni nell’ambito della cognizione e delle teorie della comunicazione stentano ancora ad affiorare e ad essere utilizzati con disinvoltura da studiosi e critici2. Proprio in questa direzione, noi cercheremo invece di incamminarci, in quello che segue.
Prologo 2 – I periodi
Gli storici – delle società, dei rapporti economici, delle credenze religiose, delle inclinazioni filosofiche, delle letterature, delle arti figurative, del teatro, della musica, delle scienze e delle tecnologie – amano in genere le periodizzazioni. Fissare i tratti caratteristici di un certo periodo, rispetto ad altri, mette a disposizione uno strumento utile, per dare ordine e incasellare accadimenti, stili, opinioni, occorrenze, legami o successioni.

Naturalmente, come sempre succede in ogni tassonomia, anche un’ottima periodizzazione può mostrare elementi di debolezza, arbitrarietà, forzature, caratteri ambigui e incerti confini. Anzi, proprio sugli elementi che contraddistinguono un determinato periodo (rendendolo diverso e specifico) possono sorgere dubbi e discussioni accanite. Tipica, sotto questo profilo, è la diatriba sugli elementi di continuità e di rottura che un certo passaggio potrebbe ammettere (oppure richiedere), per qualificarsi come frontiera di una svolta epocale. Così come è tipica l’enfasi posta – alcune volte – su differenze che potrebbero essere non essenziali; un’enfasi che ha spesso una funzione retorica: quella di affermare la presunta originalità di un certo insieme di posizioni, per proporlo come novità genuina, assoluta. Così, da quando Thomas Kuhn ha proposto la sua idea delle “rivoluzioni scientifiche” (Kuhn, 1962), in diversi campi della cultura umana le presunte “svolte paradigmatiche” si sono moltiplicate, almeno nelle presunzioni dei proponenti e dei sostenitori. In verità, malgrado il termine “nuovo” abbia un indubbio valore di sollecitazione (evocando ciò che non è scontato e risaputo), la storia della cultura umana potrebbe avere ritmi più lenti, rispetto a quelli immaginato dagli “innovatori”.
Ciò premesso, veniamo rapidamente al teatro. Veniamoci, per chiarire che – mentre ci accingiamo a discutere un aspetto particolare del teatro contemporaneo (o almeno di una sua parte esemplare, consistente nella sua presunta “de-semantizzazione”), non ci interessa stabilire se questo aspetto sia paradigmatico, così da segnalare una cesura epocale. Per essere espliciti: ci sembra ovvio che la forma drammatica non costituisca più – ai giorni nostri – una forma assolutamente necessaria per il teatro; ma sull’idea che questa condizione si sia affermata soltanto nell’ultimo quarto del secolo XX, o che sia in qualche modo una condizione destinale (tale da rendere per il futuro improponibile la stessa forma drammatica, se non come fatto residuale) condividiamo serie perplessità.

Ciò detto, resta il fatto che qui ci interessa valutare proprio la crisi (o l’abbandono) del testo; sotto un profilo specifico: quali tipi di attività cognitive sono all’opera (in luogo di quelle che riguardano la comprensione e l’interpretazione di un testo, o di un proferimento verbale), quando partecipiamo a un evento nel quale la fabula è scomposta (o addirittura assente) e la presenza della voce ha al massimo la funzione di un suono, di un rumore, di una atmosfera, non più quello di esprimere sensi e significati, estensioni e intensioni, tramite il linguaggio ordinario.
Del resto – come ha notato Jean-Pierre Sarrazac – la crisi della fabula non è cosa recente (Sarrazac, 2005, p. 78 sgg.). Emerge già all’epoca dei Lumi, quando la linea del dramma è spezzata in quadri, che mettono in secondo piano la continuità dell’azione, privilegiando frammenti e focalizzazioni: i tableau, appunto, tavole separate tra loro, portatrici di un senso specifico. E, come è noto, proprio sulla “crisi della forma drammatica” insisteva nel 1956 Péter Szondi, allievo di Lukács e paladino d’un teatro epico (Szondi, 1962). Szondi assegnava al 1880 l’inizio di questa crisi; però, piuttosto che riferirla al venire meno del contenuto del dramma, la riferiva alla forma (inadeguata, a suo dire, ai nuovi contenuti). Qui, non c’è ancora una crisi del riferimento semantico, ma una trasformazione del dramma “assoluto” (o del dramma nella vita, come lo chiama Jean-Pierre Sarrazac), al dramma della vita: alla tragedia umana, che non si compie in una giornata fatale (come nel dramma assoluto), ma copre l’intera esistenza (Sarrazac, Naugrette, 2007, p. 11).
Non è di queste “crisi” che vogliamo occuparci, ma di una “crisi” più recente: quella che è riferibile alla penetrazione aggressiva, molto potente, di arti e di corpi alieni, dentro al dramma: spazi digitali, mere virtualità, frammenti interattivi, istallazioni, trasparenze, rumori, giochi di luce, video-arte, prodotti artificiali e tecnologici, esibizione di carne, protesi, stringhe verbali deprivate di senso, sfide allo logica, disgregazione dei rapporti causali, collasso del significato e del senso3.
Ecco: quand’anche queste invasioni non mettano capo a un nuovo paradigma (e la continuità sostanziale del dramma non sia in discussione)4 , il fatto stesso che il loro utilizzo miri a produrre effetti (più che a trasmettere contenuti proposizionali) pone il problema del loro significato esperienziale e cognitivo, per coloro che si espongono ad esse. Per cercare indizi, in questo ambito, dobbiamo partire da lontano: ricordando quale sia stato il ruolo del lògos, nella nascita del teatro e nei suoi sviluppi moderni.
Egemonia del lògos
Per oltre duemila anni, gli elementi essenziali di una teoria dell’enunciazione (quanto alle regole del proferimento e dell’azione teatrale) hanno potuto essere ricondotti, con buoni argomenti, a pochi passaggi del corpus aristotelico.
Nella Poetica, Aristotele affronta il tema nei capitoli 19 e 20 (con un prolungamento nel 22). Nel capitolo 19, si limita però ad avvertire che l’ignoranza sui fondamenti della recitazione e dei suoi obiettivi non può essere imputata alla poetica (la quale non riguarda – in senso stretto – questo ambito pratico); mette così le mani avanti – per così dire – se lui stesso non sviluppa qui l’argomento. Nel capitolo 20, Aristotele elenca e definisce i “suoni della voce” che compongono il discorso (un’unità compiuta, quest’ultima, dotata di significato). Tra questi “suoni”, le parti più minute sono prive di significato (la lettera, la sillaba, la congiunzione e l’articolazione); la parti più complesse (il nome e il verbo, e le loro declinazioni) sono invece quelle in grado di esprimere qualcosa, perché dotate di significato. Infine, nel capitolo 22, Aristotele distingue l’enunciazione solenne da quella triviale, l’enigma dal barbarismo, il chiaro dal ridicolo; tuttavia, piuttosto che alla voce, riferisce queste distinzioni al testo, alla sua costruzione, allo svolgimento letterario dei fatti. L’enunciazione – in questo senso subordinato – deve essere “appropriata”; ed è appropriata quando si adegua al testo (al filo del discorso), e quest’ultimo ai fatti. È la scelta dei fatti, e della loro concatenazione, ciò che è in grado di provocare il piacere in chi assiste, oppure la compassione, la paura, l’ilarità, altri moti dell’anima. L’enunciazione, e tutti gli altri aspetti dell’azione scenica, sono dunque sottomessi al significato del testo; risultano “appropriati”, se contribuiscono a farne cogliere il significato, cioè la concatenazione dei fatti che il testo (inventa o) rappresenta.

Nella Retorica, l’elocuzione è oggetto specifico del libro terzo. Però, già nel secondo capoverso del libro, Aristotele ammette che un aspetto specifico dell’enunciare – la declamazione – “non è stato ancora sviscerato”.
La declamazione riguarda la voce, cioè come ci si debba servire di essa per ciascuna passione: ad esempio quando debba essere forte, quando debole e quando media; e quali intonazioni debba avere, se quella acuta, quella grave o quella media; e a quali ritmi a seconda di ciascun caso. Tre sono infatti gli scopi a cui si mira, riguardo ad essa: il volume, l’armonia e il ritmo. Quelli che li raggiungono ottengono per lo più le vittorie nei dibattiti, e come nei teatri al giorno d’oggi gli attori hanno maggior successo dei poeti, così anche nei dibattiti politici accade una cosa analoga, a causa del decadimento morale dei cittadini (Reth. 1403 b, trad. it. in Aristotele, 1961, p. 168).
Dopo questo accenno pessimistico all’etica della pólis (che qui risulta inversamente proporzionale alle astuzie retoriche dei declamatori di professione), nei successivi capitoli Aristotele torna ad occuparsi dell’enunciazione scritta, cioè della forma efficace del discorso a prescindere dal suo proferimento. E, presumibilmente, trascura la declamazione rispetto all’enunciazione, perché la separazione tra la cultura parlata e quella scritta si era andata affermando da poco, nelle scuole dell’Attica; da appena mezzo secolo, o poco più, rispetto agli anni della formazione di Aristotele, al suo ingresso nell’Accademia, alle sue prime riflessioni critiche sull’arte della retorica (il Grillo). È dunque ragionevole che la teoria dell’enunciazione riguardi qui il testo scritto, nel presupposto che l’enunciazione debba essere adeguata al significato e agli obbiettivi del discorso; e che la declamazione risulti a sua volta appropriata, ed efficace, quanto più sia in grado di comunicare quel preciso significato e quegli obiettivi specifici. Del resto, la polemica – tutta politica – con i sofisti doveva corroborare nel grande stagirita un’estrema diffidenza, per i discorsi o i proferimenti che non avessero alcun corrispettivo nei fatti, sia pure immaginati.
È ben vero che l’arte della retorica, col passare dei secoli, divenne addirittura una Istitutio (Marco Fabio Quintiliano, I secolo d.C.), poi un’arte liberale (Marziano Capella, V secolo d.C.) ed infine una vera e propria scienza dell’argomentazione (Chaim Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca, Traité de l’argumentation. La nouvelle rhétorique, 1958). Così come è vero – a proposito degli schemi melodici dell’emissione vocale – che già nella riflessione sui “modi” del canto gregoriano Guido d’Arezzo postulava un rapporto diretto tra questi e le emozioni (Micrologus disciplinae artis musicae, 1026). Così come è vero che già dal XVIII secolo l’arte della recitazione ha iniziato a distinguersi da quella oratoria (Luigi Riccoboni, Dell’arte rappresentativa, 1728).
Del resto, già nel Simposio e nel Fedro platonici, più che all’oggettiva potenza dei fatti e alla logica degli argomenti il successo di un atto comunicativo era riferito alla seduzione, al fascino, al valore erotico dei parlanti; oppure, alle disposizioni di chi ascolta, alle sue propensioni, alle aspettative o credenze. Tuttavia, quale che risulti in effetti il contributo di questi elementi extra-linguistici nella comunicazione ordinaria, politica, scientifica, letteraria o drammatica, per oltre due millenni è rimasto sostanzialmente accettato il presupposto che il contenuto concettuale di un atto di comunicazione (il suo significato, e il suo senso, espressi in una forma verbale o riducibili a questa) è dirimente, quanto alle intenzioni del locutore e al successo effettivo dell’atto. Con la “svolta linguistica” (Frege, 1884) e con l’affermarsi dell’idea secondo la quale l’intera semiologia può essere considerata come una parte della linguistica (Barthes, 1964), questa impostazione ha continuato a prevalere, per buona parte del secolo scorso5.
Bücherverbrennungen
Come abbiamo già anticipato nelle premesse, a due millenni e mezzo dalla nascita del teatro classico è accaduto che sia venuto meno in molti casi il presupposto logo-centrico, e che alcuni aspetti extra-linguistici (o para-linguistici) dell’azione teatrale siano arrivati (a volte) a prendere il sopravvento6. Gli esempi sono moltissimi e noti. Bisognerà citarne qualcuno, come spunto e parametro del nostro ragionamento.

Possiamo considerare, come primo esempio, il molto citato A Letter For Queen Victoria di Robert Wilson (1974). Qui, viene messo in scena un “dialogo” (volutamente) privo di significato, tra l’autore e un ragazzo autistico: questo “dialogo” consiste soltanto nell’emissione di suoni privi di significato, che sembrano avere un valore puramente musicale (essendo accompagnati, del resto, dalla percussione di pezzi di legno). In altri momenti dell’opera, i proferimenti del ragazzo sono parole ripetute ossessivamente, ormai private di denotazione. Altri nove attori entrano in scena a loro volta, recitando frammenti di conversazioni ordinarie, prive tra loro di qualsiasi coerenza. Il “personaggio” principale dell’opera è in definitiva il linguaggio, che risulta però polverizzato, quanto al contenuto semantico e alla consistenza sintattica.
Ein Sportstueck di Elfriede Jelinek (1998) può funzionare da secondo esempio. In questo caso, tutta la partitura è programmaticamente musicale, costruita su una tessitura di citazioni desunte dalla letteratura pop, dalle soap opera, da testi di Kleist e von Hofmannsthal, da istruzioni legate a pratiche sportive, da espressioni razziste, antisemite o sessiste. Lavorando sugli aspetti fonetici e sintattici di questo materiale sonoro, Jelinek ha costruito una partitura di base, alla quale il direttore dell’opera (Einard Schleef) ha aggiunto altre citazioni musicali e verbali, affidate all’esecuzione di un consistente gruppo di attori/danzatori. Il risultato (un’onda sonora e visiva, durata alcune ore, modulata dai reciproci assalti dei vari gruppi di performer) è alla fine dei conti un oggetto privato di ogni aspetto semantico; o, almeno, un oggetto nel quale resta ben poco dei singoli frammenti testuali, considerando l’opera nella sua interezza.
Nella messa in scena del Giulio Cesare shakespeariano, ad opera di Romeo Castellucci (1997), la parte di Marco Antonio è affidata a un attore laringectomizzato. Durante l’orazione funebre, la voce stridente dell’attore è accompagnata dall’immagine endoscopica della sua gola, che si contrae per lo sforzo. E, per deformare anche la voce di Marco Giunio Bruto, rendendola più acuta, è previsto che l’attore che lo interpreta inali una dose di elio, prima di entrare in scena. Anche qui, la tensione che si viene a creare tra il testo originale e questa specifica occorrenza dello spettacolo allude al fatto che la comunicazione teatrale non è, per logica necessità, subordinata al testo, al significato delle parole, alla loro declamazione ordinaria. Si tratta, del resto, di un assunto sviluppato con sistematicità dalla Socìetas Raffaello Sanzio nella Tragedia Endogonida (2002-2004): gli undici episodi della Tragedia si aprono con un suono indistinto (una sorta di respiro, che è insieme umano, animale e cosmico). Poi, questo suono/rumore lascia spazio alla voce umana, che degenera presto in urla e lamenti. Il testo verbale sembra riprendere un ruolo, quando viene finalmente proiettato su uno schermo; però, mentre le immagini scorrono avanti, il testo viene come “frullato”, e la voce che lo sta leggendo si trasforma di nuovo in rumore7.

Infine, si può ricordare The Skriker, di Caryl Churchill (1994). Viene qui messa in scena l’origine stessa del linguaggio, secondo un mito nordico dell’Inghilterra. La fata Skriker, messa in scena dalla Churchill, si esprime in un idioma pre-verbale, pieno di musica e di sensualità, molto ricco di sibilanti e fricanti. Questa lingua vorrebbe essere magica e subliminale, adatta a una chora; appropriata cioè a quel ricettacolo materno e primordiale, che veniva evocato nella cosmogenesi antica e che è stato ripreso qualche decennio fa da Julia Kristeva, nella sua lettura di Mallarmé: «indifferente al linguaggio, enigmatico e femmineo, questo spazio soggiacente allo scritto è ritmico, privo di vincoli, irriducibile a una traduzione verbale intellegibile; è musicale, anteriore al giudizio» (Kristeva, 1974, p. 28, trad. mia). Ciò che risulta essere vero e originale – in quest’opera teatrale composta alla fine del secondo millennio – è insomma qualcosa di profondamente diverso, rispetto agli enunciati che corrispondono a fatti oggettivi, cui si riferiva Aristotele nella sua Poetica e nella sua Retorica del quarto secolo a.C.
Si potrebbe continuare, con decine d’esempi. Retrodatandoli semmai, se è vero che già Gordon Craig (Art of Theatre, 1911), Stanisław Ignacy Witkiewicz (Teatr. Wstęp do teorii Czystej Formy w teatrze, 1923), Gertrude Stein (Plays, 1935), Antonin Artaud (Le théâtre et son double, 1938) e molti altri avevano già perorato la decostruzione dei testi e l’emancipazione dal linguaggio del teatro, concepito a quel punto come una forma di presentazione che può essere liberata dalla narrazione di fatti, dalla costruzione di intrecci e dalla espressione verbale di storie, stati o eventi. Proprio sull’emancipazione del teatro dal testo letterario ha insistito la riflessione di Hans-Thies Lehmann sul “teatro post-drammatico” (Lehmann, 1999), cui abbiamo già accennato nelle premesse8. Si tratta di un “paradigma” ben noto, perché convenga insistere.
Ventagli. Congedi
Più in generale, invece d’occuparci di aspetti tassonomici (oppure normativi), che individuino (o impongano) alcuni tratti caratteristici del teatro attuale (e, più in generale, delle performance), basterà osservare che le scene più accreditate, a noi coeve, presentano un ventaglio molto largo di offerte, lungo un continuo che vede, ad un estremo, opere che potrebbero ancora candidarsi a premi letterari (per esempio al premio Nobel, come accade sovente, nella sezione riservata alla letteratura); all’altro estremo, opere la consistenza letteraria delle quali è assente o marginale, e sono assimilabili piuttosto a una partitura musicale, a una coreografia, a una composizione di effetti luce, a drammaturgie sonore, a costruzioni di atmosfere dal significato impreciso, entro le quali si può solo navigare coi sensi. In questo largo ventaglio, tra i due estremi, c’è una moltitudine estremamente intricata di prodotti ibridi, per i quali il rapporto con linguaggio e col testo non sembra necessariamente antagonistico, ma nemmeno di subordinazione9. Tracciare discriminanti, per isolare la specifica “attualità” di un certo teatro, o di una certa performance, è sempre possibile; però, piuttosto che dar conto del carattere effettivo (e multiforme) della drammaturgia contemporanea (e dei suoi esiti), criteri selettivi di questo genere potrebbero rivelarsi – sotto il profilo logico – delle pure definizioni (dettate da pregiudizi estetici, sociali, filosofici), riducendo quella presunta attualità a una questione terminologica, a un truismo). E questo, si badi bene, senza negare affatto le cesure, le innovazioni, le trasformazioni e i rivolgimenti che la cultura e la tecnica dell’era contemporanea hanno indotto, in questo terreno specifico dell’espressione e dell’intelligenza umana.
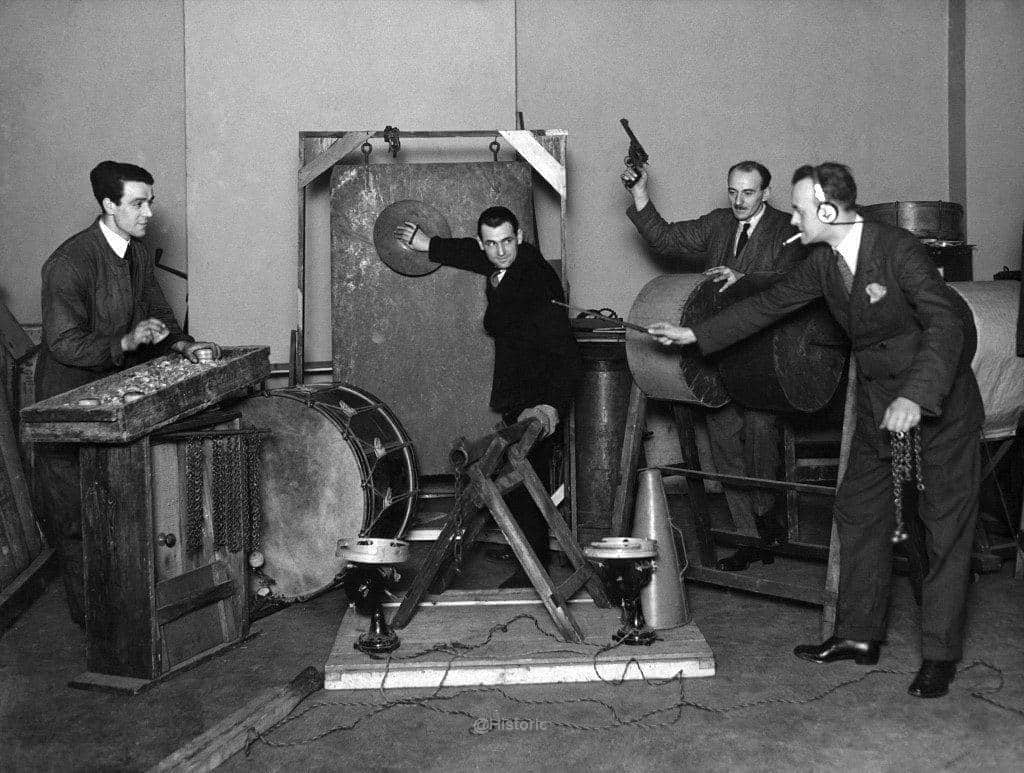
Mi spiego meglio. Se dico per esempio: «è attuale (nella cultura artistica) soltanto ciò che tiene conto delle tecnologie di ultima generazione, e ne è anzi uno specifico (ed esclusivo) prodotto», io ho introdotto un criterio fortemente selettivo ma: 1) rischio di tagliare fuori da questa presunta attualità la stragrande maggioranza dei prodotti culturali validi e correnti; e: 2) ho selezionato in verità le tecnologie “di ultima generazione”, piuttosto che i prodotti artistici (e la selezione di questi secondi è un risultato banale della prima scelta, e della definizione introdotta). In conclusione: considerazioni fattuali e metodologiche consigliano un atteggiamento più tollerante e comprensivo, nel riferirsi al teatro contemporaneo e alle sue specifiche caratteristiche.
Del resto, c’è una novità di pensieri, di abilità, di condizioni, di conoscenze di sfondo, di gusti – nell’era contemporanea – che non è riferibile soltanto (o riducibile) alle innovazioni di tipo tecnologico; lo affermo, senza mettere in dubbio la rilevanza di queste innovazioni, nel determinare e nel condizionare quei pensieri, quella abilità, quegli stati e quelle conoscenze.
In un panorama così articolato, eterogeneo e vasto, c’è da chiedersi se resti qualcosa di unificante, per una teoria che si candidi a cogliere tutto questo complesso: qualcosa di analogo, per esempio, al ruolo che aveva il testo nella teoria aristotelica dell’enunciazione; qualcosa che renda possibile individuare – mutando tutto quello che c’è da mutare – uno specifico valore del teatro e delle performance, ai giorni nostri.
Sulla scorta della posizione aristotelica (che riguarda in fin dei conti la comunicazione, e in particolare l’influenza sulle passioni e il mutamento delle opinioni di chi ascolta), si potrebbe immaginare ad esempio che il valore specifico di un’azione teatrale, anche ai giorni nostri, sia legato agli effetti cognitivi, affettivi, comportamentali e performativi che quest’azione riesce a produrre; e che però – piuttosto che al discorso, al significato del testo (e all’enunciazione di questo) – il valore e la potenza del teatro dipendano da aspetti che non sono meramente linguistici, ma che hanno a che fare anche (e, forse, soprattutto) con competenze di tipo pre-linguistico o extra-linguistico; e – più in generale – con elementi della comunicazione che attengono alla sfera della pragmatica. Un’ipotesi del genere, per altro, non riguarderebbe soltanto il teatro che ci è più vicino e coevo; si può immaginare – quale che fosse l’opinione di Aristotele – che alcuni aspetti pragmatici fondamentali della comunicazione umana fossero all’opera già nel teatro classico (e persino in quello rituale dei “primitivi”), al di la della mera concatenazione dei fatti rappresentati sulla scena (e del discorso che il testo – secondo Aristotele – ne esprime linguisticamente l’intreccio).
Per costruire l’embrione di un’ipotesi di questo tipo, dobbiamo però congedarci da due tradizioni eminenti, che hanno affrontato lo stesso tipo di problema, nell’ultimo quarto del secolo scorso. La prima tradizione è sicuramente robusta, soprattutto in questo campo: si tratta dell’approccio semiologico, incline a trattare come segni tutte le componenti dei sistemi che comunicano qualcosa. La seconda tradizione è invece quella psicoanalitica (e quella lacaniana in particolare), incline ad attribuire all’inconscio una struttura analoga a quella del linguaggio (e a riferire le competenze prelinguistiche degli umani alla loro particolare ontogenesi: soprattutto, al rapporto diretto con i corpi e con le voci, nelle primissime fasi dell’esistenza). Queste due illustri tradizioni, per le ragioni che cercherò di raccogliere in poche battute, costituiscono un ostacolo reale per una teoria dell’azione teatrale che sia legata invece alla pragmatica del linguaggio, agli aspetti cognitivi della comunicazione, alla fenomenologia e alla natura degli affetti, al ruolo del contesto, a quello delle credenze, delle intenzioni e delle conoscenze di sfondo. Vediamo con ordine.
Teatralità, non-segni
In una intervista del 1961, dedicata rapporto tra letteratura e significazione, Roland Barthes (Barthes, 2002, p. 258) domandava a se stesso: «Cos’è il teatro?». La sua risposta ruotava intorno all’idea che il teatro fosse una sorta di “polifonia informazionale”. Ovvero: “uno spessore di segni”, recanti ognuno informazioni (circa la scena, i costumi, le luci, la disposizione degli attori, i loro gesti, le loro espressioni, le loro parole), alcune delle quali più stabili (la scena, i costumi), altre più labili (le parole, i gesti). Così, come nella polifonia, il contrappunto tra queste informazioni è in grado secondo Barthes di generare l’insieme: il teatro, appunto.

In uno scritto precedente, del 1954, lo stesso Barthes aveva definito la “teatralità” come il “teatro meno il testo”, cioè come il complesso «degli artifici sensuali, gesti, toni, distanze, sostanze, luci, che sommerge il testo con la pienezza del suo linguaggio esteriore» (Barthes, 2002, p. 28). Dunque, restando fedeli a questa definizione di Barthes, potremmo dire che la teatralità di un’opera (in una specifica occorrenza) è costituta dalla sua “partitura informazionale” (per quella particolare occorrenza), cui è stata sottratta però la linea del testo. Oggi, per le ragioni che dirò tra breve, parleremmo forse degli aspetti “para-linguistici” dell’azione teatrale, o dei suoi aspetti “para-teatrali”; parleremmo di questo, piuttosto che di “teatralità” (o di una “partitura polifonica monca”; e che, per giunta, sarebbe “monca” della sua parte più rilevante, in tutti quei casi che non si iscrivono più nella tradizione del dramma).
Già: così come il termine “para-linguaggio” denota l’insieme delle componenti (del linguaggio) che prescindono dal contenuto verbale (i tratti prosodici, come l’intonazione, il ritmo, la durata, l’accento, più le qualità tipicamente vocali, come l’altezza, l’intensità, il timbro, più eventualmente gli altri elementi sonori che accompagnano la produzione vocale, come il riso, i lamenti, singulti, i colpi di tosse, i balbettii, eccetera), così possiamo chiamare “para-teatrali” le componenti (del teatro) che prescindono dal contenuto verbale del testo. Le note di regia, o le indicazioni dell’autore (anche quando siano espresse in una forma meramente verbale) rientrano in questa categoria.
Ora, l’interrogativo è appunto: le componenti del para-teatro (o della teatralità, per dirla con Barthes) hanno a loro volta una struttura di tipo linguistico? Sono “segni” dotati di un codice, nel senso pieno del termine? Oppure, per dirla in modo più semplice (senza comprometterci sulla presenza di un codice e sulla struttura linguistica): le componenti del para-teatro sono l’unione di specifici significati e significanti? Fungono da referenti, che possiedono un preciso contenuto referenziale? Su queste domande, all’apparenza assai rarefatte, si gioca in ultima analisi la competenza della semiotica (o della semiologia, per dirla sempre con Barthes), nel dare risposta alla questione fondamentale che qui abbiamo posto: quali sono gli effetti cognitivi, affettivi, comportamentali e performativi che un’azione teatrale riesce a produrre, in un’epoca di crisi (o di arricchimento?) del dramma tradizionale e di apparente rarefazione del dominio del testo?
Per anticipare (mediante un enunciato puramente condizionale) una valutazione non prevenuta sul possibile ruolo della semiologia in questo ambito, poniamo la cosa in questo modo: se le componenti para-teatrali non sono segni, allora non si vede come la scienza dei segni possa darne conto. La semiotica, o la semiologia, offrirebbero strumenti spuntati, in questo campo.
Bisogna richiamare, a questo proposito, un punto di dottrina al quale abbiamo già fatto cenno: nell’accettare il programma di ricerca di Ferdinand de Saussure (la costruzione di una scienza generale dei segni), Barthes (Barthes, 1964) assume che la semiologia debba essere considerata come parte della linguistica. Infatti, per Barthes, soltanto nel linguaggio è possibile analizzare il significato delle forme di significazione che si danno nella società e nella cultura; in particolare, nel cinema, nella pubblicità, nella moda e nella televisione.
Veniamo dunque al teatro; e, soprattutto, agli esempi più radicali della teatralità contemporanea, per i quali l’aspetto meramente iconico o sonoro tende a prevalere, rispetto alla struttura verbale del testo. Quale potrebbe essere la potenza esplicativa della semiologia, in questo ambito? Una risposta molto deludente la fornisce lo stesso Barthes, analizzando il caso della pittura e della musica.

In uno scritto del 1969, intitolato “La pittura è un linguaggio?”, la risposta di Barthes rivela imbarazzo: per la pittura, è arduo stabilire un lessico, fissare una grammatica, distinguere i significati dai significanti, individuare regole di sostituzione e di combinazione, eccetera. In breve:
La semiologia, come scienza dei segni, non aveva presa sull’arte: impasse deplorevole, perché finiva col rafforzare l’antica idea secondo la quale la creazione artistica non può essere “ridotta” a un sistema; il sistema, si sa, è considerato nemico dell’uomo e dell’arte (Barthes, 2001, p. 149).
Poi, in verità, una pseudo-soluzione di questa impasse imbarazzante Barthes la propone, ricorrendo alle interpretazioni verbali delle opere d’arte: ogni quadro – nella concezione di Barthes – può essere considerato come un sistema che esibisce una relazione uno-a-molti con le sue descrizioni verbali, potenzialmente illimitate:
Il quadro, da chiunque sia scritto, esiste solo nel racconto che ne offro; o meglio: nella somma e nell’organizzazione di letture che se ne possono dare: un quadro non è mai altro se non la propria descrizione plurale (Barthes, 2001, p. 150).
Si può restare sconcertati, rispetto alla riduzione ontologica dei prodotti delle arti visive alle loro (potenzialmente infinite) descrizioni; ma la cosa meraviglia poco il filosofo, avvezzo alle stranezze contro-intuitive della “svolta linguistica” del XX secolo. Verrebbe allora da dire: in luogo dei quadri, riempiamo i musei di descrizioni; e, nei teatri (quanto agli aspetti meramente visivi e sonori della teatralità), offriamo descrizioni verbali, eliminando del tutto quell’apparato di luci, di colori e di effetti che potrebbero essere davvero uno spreco, se essi “non sono altro che” … la loro descrizione.
Più sobriamente, in una intervista del 1961 (già citata in precedenza), Barthes ammetteva che:
la “sostanza” [di un quadro figurativo] (per parlare come i linguisti) è costituita da linee, colori, rapporti che non sono significanti di per sé (al contrario della sostanza linguistica che serve solo e sempre a significare) (Barthes, 2002, p. 264).
Ecco: i presupposti teorici della semiologia portano ad escludere che le immagini puramente visive siano “segni”. Tanto basti, per ora, quanto ai rapporti tra le arti visive e la semiologia. Veniamo invece alla musica.
La musica, per Barthes, è un “campo di significazione”, ma non è un sistema di “segni”. Il “tessuto” di questo campo di significazione è costituito per Barthes da figure del corpo (i “somatemi”); cioè, per esempio: gli stiramenti, i colpi, i quasi parlando, i raggomitolamenti, gli strappi, i brontolii e così continuando (Barthes, 2001, p. 287 sgg.). Ascoltando ad esempio il ciclo di pezzi Kreisleriana di Schumann, Barthes dichiara di non sentire «nessuna nota, nessun tema, nessun disegno, nessuna grammatica, nessun senso, nulla che permetta di ricostruire una struttura intellegibile dell’opera». Schumann, scrivendo l’opera, avrebbe costruito soltanto una sequenza di movimenti del corpo. Il vero referente di questo ambito, piuttosto che la musica, sarebbe allora il corpo. In un contesto del genere, anche se nessuna unità particolare dell’opera (ogni nota) è in sé significante, l’insieme risulterebbe provvisto per Barthes di significanza (Barthes, 2001, p. 298). Ma questa significanza – si badi bene – non avrebbe affatto la struttura del linguaggio; semmai, quella del desiderio. Dunque, la musica – secondo Barthes – non è un sistema di segni; e il campo di significazione ha un referente (il corpo) che non ha a sua volta alcuna struttura linguistica. Provi dunque la semiologia, conclude Barthes, a «venire a capo, se vi riesce, del sistema delle note, delle gamme, dei toni, degli accordi, e dei ritmi; ciò che noi intendiamo percepire e seguire, è il formicolio dei colpi» (Barthes, 2001, p. 299). Due anni dopo, nel 1977, Barthes avrebbe ancora annotato:
che cos’è dunque la musica? […] è una qualità di linguaggio. Ma questa qualità di linguaggio non ha nulla a che fare con le scienze del linguaggio (poetica, retorica, semiologia), perché, col divenire qualità, nel linguaggio viene ad accentuarsi ciò che non dice, ciò che non articola. Nel non detto, vengono a collocarsi il godimento, la tenerezza, la delicatezza, la soddisfazione, tutti i valori più delicati dell’Immaginario (Barthes, 2001, p, 273).
E fermiamoci qui, quanto alla potenza esplicativa della semiologia, nel campo delle arti visive e della musica.
Vale tuttavia il caso di aggiungere una considerazione di carattere più generale, nei confronti delle discipline che insistono sul concetto di segno, come chiave di volta della significazione, della comunicazione e della comprensione.

Olfatto
Negli stessi anni in cui Barthes sviluppava le considerazioni sulla musica che abbiamo richiamato qui sopra, un giovane studioso di antropologia, di pragmatica e di psicologia – Dan Sperber, oggi una delle figure più eminenti nel campo della teoria della comunicazione, della trasmissione culturale e della psicologia evoluzionistica – pubblicava il volume Le Symbolisme en général (Sperber, 1974); un libro che molti considerano oggi una sorta di pietra tombale del simbolismo, e in particolare dell’idea che le conoscenze di sfondo presenti in ogni cultura possano essere seriamente considerate come i significati impliciti (e taciti) di certi simboli pubblici (i significanti). Oltre che dai risultati di campagne personali nel sud dell’Etiopia, la critica di Sperber prendeva le mosse da un semplice caso elementare – l’odore – che sembra davvero in grado di mettere in crisi i fondamenti cognitivi del simbolismo (Sperber, 1974, ed. ingl. p. 115 sgg.). Vale la pena di richiamare i termini essenziali dell’argomentazione di Sperber, perché anche l’odore potrebbe essere considerato come uno degli elementi para-teatrali che sono in grado di riempire il contesto di una certa performance; dunque, potrebbe essere utile analizzarne – se è il caso –l’eventuale natura simbolica.
Bene: l’odorato umano può distinguere centinaia di migliaia di odori (così come accade del resto per le nuance della vista o dell’udito), ma in nessuna lingua del mondo esiste una classificazione degli odori comparabile – per esempio – a quella dei colori. In genere, la classificazione degli odori rinvia alle loro cause (“un odore d’incenso”) o ai loro effetti (“un odore nauseabondo”). E non sembra nemmeno possibile una tassonomia di classi e sottoclassi (di tipo gerarchico, analoga a quella dei colori), oppure fondata su criteri di compatibilità e di esclusione. Si possono forse rilevare dei cluster, basati su criteri di vicinanza o di distanza; o legati alle determinanti causali; ma ogni classificazione di un cluster che rinvii alle cause (basata, per esempio, sull’odore dei fiori) sarebbe una classificazione delle cause, non degli odori. In breve: gli odori non mettono capo a un campo semantico autonomo; sono invece parassitari, sotto il profilo semantico, rispetto ad altri campi. Gli odori hanno inoltre la particolarità di poter essere riconosciuti (ed è quindi plausibile che rimangano a lungo termine nella memoria), ma è estremamente difficile richiamarli alla memoria senza stimoli attivi: di una mela, nella memoria a questo deputata, è abbastanza facile richiamare la forma (l’immagine visiva); più arduo è richiamarne il profumo. Questo debolezza del richiamo mnestico potrebbe essere proprio legata all’assenza di un campo semantico, relativo agli odori.

Succede però che gli odori siano simboli per eccellenza. Infatti, già nel 1756 Carlo Linneo aveva immaginato che la funzione dei distillati delle piante (relativamente alle loro capacità farmacologiche) fosse riferibile al corrispondente odore. L’assunto (sotto il profilo empirico) non tiene; ma dà conto del fatto che agli odori possa essere attribuita una forte natura simbolica, nell’esperienza umana. Altri odori, come l’incenso, hanno acquistato un valore simbolico grazie alla loro istituzionalizzazione cerimoniale. Però, è soprattutto all’interno di ogni particolare individuo che gli odori hanno una specifica funzione simbolica, per il loro carattere evocativo di esperienze pregresse, che hanno segnato il vissuto. Ed il fatto che la semiologia non sia in grado di rendere conto di questo aspetto dell’esperienza ordinaria conferma di nuovo la sua debolezza, nei confronti «di quei fenomeni simbolici che eludono ogni forma di comunicazione codificata e stabiliscono invece legami diretti tra la natura osservata e lo stato interno dell’osservatore» (Sperber, 1974, ed. ingl, p. 118). Una debolezza, dunque, che riguarda proprio la ricezione privata di esperienze pubbliche e condivise. Ciò dunque basti, per ora, quanto alla chance analitiche (e alla competenza esplicativa) della semiologia, sugli aspetti para-teatrali dell’azione teatrale.
Di specchi e inconsci
Vengo dunque all’altra tradizione, quella psicoanalitica, che può oggi costituire paradossalmente un ostacolo, nel decifrare i modi che permettono agli umani di partecipare e di godere dell’esperienza teatrale; che permettono loro di farlo, nonostante sia recentemente accaduto un fatto strano (se si guarda al teatro con occhio aristotelico): il ruolo d’una caratteristica specifica e molto preziosa – il linguaggio, la parola, il verbo – è stato per molti versi declassato, da individui assai colti della specie homo sapiens (artisti di mestiere), quasi pentiti dell’antico peccato originale (Genesi 3, 6), legato appunto al logos. Mi farò guidare – nel richiamare alcuni aspetti di questo “ostacolo” – da alcuni spunti del lavoro densissimo di una studiosa della voce a teatro, Helga Finter (Finter, 2014).
Cercando un luogo, un tempo, una ragione che possa dare conto di quel legame fortissimo che lega gli individui della nostra specie alle emissioni vocali (anche quando queste siano prive di qualsiasi significato particolare), Finter torna a una fase particolarissima dell’ontogenesi, che precede addirittura il riconoscimento e la costruzione del sé. A questa fase originaria, ineludibile, successiva alla nascita e condivisa dall’intera specie, Finter attribuisce la sensibilità particolarissima che gli esseri umani esibiscono, rispetto al suono della voce (comunque questo sia espresso, anche a prescindere dai codici e dai significati). Questa esperienza primordiale (nella lettura che Finter accetta) non riguarderebbe soltanto l’udito: riguarderebbe il corpo nel suo complesso, che in quella fase originaria è connesso inestricabilmente alla voce. Per estensione, si potrebbe anzi immaginare che questa sensibilità tutta umana riguardi anche altre modalità percettive ed espressive, e consenta dunque di dare in qualche modo conto degli effetti cognitivi, affettivi, comportamentali e performativi che noi sperimentiamo, quando siamo esposti a certi specifici eventi teatrali. Come se quegli eventi, insomma, richiamassero in noi esperienze originarie, costitutive di ogni persona. E come se, essendo esposti a una crisi dei sistemi di significazione, fossimo ogni volta sfidati a ricomporli, ripercorrendo in qualche modo il nostro stesso processo di soggettivazione. Vediamo meglio.

Il punto di partenza – per Finter – è il riconoscimento del fatto che il teatro contemporaneo ha conosciuto una decostruzione della dominanza logocentrica, che ha investito il rapporto tra i differenti sistemi significanti (Finter, 2014, p. 55). Tra questi sistemi (oltre a quello verbale), Finter considera anche quello visivo e quello auditivo (malgrado sia dubbio – come abbiamo già rilevato – che questi “sistemi” abbiano le caratteristiche pertinenti e necessarie, previste dalla semiologia). La crisi della dominanza logocentrica – provocando uno smottamento dei meccanismi di fissazione del senso – richiede secondo Finter continui aggiornamenti dei processi di significazione:
L’attante, l’azione, il tempo e lo spazio di questo teatro non hanno referenti preesistenti e predeterminati; viene creato un significante potenziale [sottolineatura mia] che non significa altro che questo: la sua differenza con i codici del teatro e della vita quotidiana (Finter, 2014, trad. mia).
Però – nota Finter – ogni nuovo processo di significazione porta con sé (o presuppone) un nuovo processo di soggettivazione, di ricostruzione della soggettività; una nuova nascita, verrebbe da dire, che replichi e adatti ai tempi correnti il costituirsi come soggetto dell’essere umano. Giunge allora, proprio a questo proposito, il richiamo a quella fase originaria, nella quale il soggetto umano comincia a costituirsi, sulla base delle prime esperienze corporee e vocali. Ma lasciamo parlare Finter, a questo proposito:
Ci sono delle caratteristiche vocali che attraversano tutte le lingue, anche perfettamente parlate, e ne fanno una sorta di segnatura: sono il timbro e il mélos personale. Si tratta di due tratti rilevanti sia per il corpo fisico che per quello psicologico [psyché]: il timbro […] è influenzato da fattori di carattere fisico – tra cui la forma della laringe e delle corde vocale, insieme allo spettro ormonale del soggetto – e da fattori psichici – tra cui i modelli parentali, sessuali e culturali; il mélos personale, d’altro canto, o è il ritmo e la melodia del fraseggio […] tributari della costituzione fisica del soffio, ma anche del rapporto psichico con la lingua e col corpo, influenzato dai modelli parentali e culturali.
A un livello più intimo, la voce è soffiata dalla voce materna e da quella, paterna, della lingua […] Come la parola, la voce è soffiata, perché non soltanto ogni lingua presuppone per la sua prosodia una voce specifica, un soffio un corpo, ma ogni voce è anche un elemento costitutivo del soggetto, nella sua psicogenesi […].
[La voce] funziona da intermediario [tra corpo e linguaggio], non è un mezzo di comunicazione [média], non è uno strumento, non è un semplice organo. Piuttosto, è un oggetto transizionale [un sostituto del legame madre-figlio, nel senso di Winnicott], che permette di esplorare nella psicogenesi un corpo sonoro primario, un involucro sonoro riecheggiante. Questa prima voce conferisce [al neonato] una prima immagine acustica non separata [perché legata al suo corpo, e a quello della madre], una chora – termine ripreso in questo senso da Platone, da Julia Kristeva. Già prima che si formi un’immagine speculare dell’io, nello stadio lacaniano dello specchio, c’è un’immagine vocale, condizione perché possa stabilirsi un linguaggio affettivo col linguaggio verbale, il cui avvento rimodellerà la struttura del soggetto nella terza tappa della psicogenesi [quando il bambino riconosce la sua immagine speculare, come immagine del proprio corpo] (Finter, 2014, pp. 357-358, trad. mia).
Abbiamo già ricordato, più sopra, che questo modello della psicogenesi è stato assunto da Caryl Churchill nel 1994, come spunto per il suo The Skriker (una delle opere che abbiamo citato come caso esemplare, nel tentativo di emancipazione dal dominio del linguaggio, in una parte significativa del teatro contemporaneo). Quel che qui interessa, non è però giudicare la plausibilità di un modello del genere per l’ontogenesi, per la costruzione dell’identità personale. Né, tantomeno, interessa stabilire se la chora del Timeo platonico, oppure il ricettacolo della materia originaria cui Aristotile accenna nel libro Z della Metafisica, possano essere assimilati o ridotti all’utero o al seno materno, con un gran salto dalla cosmogenesi, alla psicogenesi e all’ontogenesi. Si tratta in ogni caso di immagini attraenti, rispetto alle quali l’acribia filologica indurrebbe al sorriso. Quel che invece interessa è capire se il riferimento all’origine degli esseri umani, alle modalità particolari della costruzione dell’io (in homo sapiens) possa dire davvero qualcosa sugli effetti cognitivi, affettivi, comportamentali e performativi che l’azione teatrale riesce a produrre, anche quando tende a sganciarsi radicalmente dal linguaggio ordinario, e fa invece prevalere quegli aspetti che abbiamo chiamato “para-teatrali”. Più esattamente: ci interessa discutere quale possa essere il ruolo della psicoanalisi – e di quella lacaniana in particolare – nel dar conto del fatto che l’esperienza teatrale riesce a produrre il piacere, la compassione, il timore, lo sdegno, l’ilarità, altri moti dell’anima (cioè gli effetti indicati da Aristotele nella sua Poetica), anche quando il significato del testo diventa evanescente e altri elementi riempiono invece la scena.
A questo riguardo, l’unica precisazione filologica che ci può forse servire concerne proprio lo “stadio dello specchio” e la sua collocazione nell’arco dell’esistenza umana. Posto che il riconoscimento della propria immagine allo specchio dica qualcosa, quanto alla costruzione della soggettività, bisogna infatti ricordare che lo stesso Lacan – nel corso della sua complessa riflessione – è giunto a concepire questo “stadio” in modo differente, modificandone il ruolo e la collocazione. Se nel 1936 (e fino a circa il 1949) lo stadio dello specchio veniva collocato in una fase precisa dello sviluppo del bambino (tra i sei e i diciotto mesi di vita), già nei primi anni Cinquanta il rapporto con la propria immagine diventa invece per Lacan una struttura permanente della soggettività:
[Lo stadio dello specchio] è un fenomeno al quale io assegno un duplice valore. In primo luogo, ha un valore storico, in quanto segna un punto di svolta decisivo nello sviluppo mentale del bambino. In secondo luogo, esso caratterizza una essenziale caratterizzazione di carattere libidinale con l’immagine del corpo (Lacan, 1953, p. 14, trad. mia).
Lo spunto è interessante. Infatti, anche ammesso che i primi mesi di vita abbiano qualche rilievo nella formazione dell’individuo, altre fasi concorrono in modo determinante alla sua costituzione. Sottovalutare il ruolo di questo processo, di queste fasi ulteriori, significa sposare paradossalmente una concezione deterministica delle caratteristiche e delle competenze di ogni persona, riferendole tutte alla fase dell’allattamento, alla neotenia.

Altre sono invece, plausibilmente, le fasi che concorrono alla formazione dell’individuo. Una di queste, per esempio, è quella che concerne la capacità di meta-rappresentare, di riconoscere cioè le proprie rappresentazioni come tali e di figurarsi le rappresentazioni degli altri. Questa fase, che i bambini normo-dotati raggiungono intorno ai quattro anni, è decisiva per lo sviluppo dell’autocoscienza e per la comprensione delle intenzioni altrui. Né ci sentiremmo davvero di trascurare la fase puberale, nella quale la produzione d’ormoni sviluppa la sessualità e nuove forme del desiderio. Infine, e non ultima, l’educazione culturale, che espone gli umani alla scienza, all’arte, al diritto e alla storia. Quale che sia, in questo quadro, il contributo formativo della fase che precede il riconoscimento allo specchio, riesce davvero difficile immaginare che il rapporto con l’azione teatrale negli esseri umani possa prescindere dalla loro successiva esperienza e formazione. Per questo, è davvero difficile accettare che la nostra relazione complessa con il teatro (con le voci, i suoni, i corpi, le immagini e le visioni), sia riferibile (in modo essenziale, e quasi obbligato) ai primi mesi della nostra vita, alle prime esperienze tattili, a quelle visioni precarie, ai sussurri materni, ai nostri vagiti.
Ma c’è un punto di rilievo maggiore (decisivo in Lacan e nella sua prospettiva), che rende davvero difficile accogliere il suo impianto analitico o quello dei suoi epigoni, per gli scopi che qui ci proponiamo. Il fatto che gli esseri umani siano in grado di produrre e di cogliere un ventaglio assai ampio di elementi para-teatrali (accanto al testo, se questo esiste, espresso in forma verbale) rinvia plausibilmente a competenze specifiche della nostra specie, la quale deve avere avuto modo di svilupparle, sotto il profilo filogenetico e ontogenetico. Queste competenze riguardano in particolare la produzione, la trasmissione, la condivisione e la comprensione di opere complesse, multimodali; quindi, per dirla in breve, si tratta probabilmente di competenze che hanno a che fare tutte con la cognizione (ma vedremo anche, tra breve, cosa possano contare gli affetti, in questa prospettiva). Ora, avendo più sopra ricordato che molti elementi dell’azione teatrale (classica e contemporanea) non possiedono una struttura propriamente linguistica (né possono essere considerati simboli, in senso proprio), sarebbe ben strano che le competenze, i sistemi o le funzioni in grado di cogliere questi elementi risultino essere elaboratori di simboli, cioè strutture dedicate alla produzione, elaborazione o ricezione di strutture linguistiche. Dunque, il punto più critico della posizione lacaniana – in un quadro del genere – risiede proprio nel fatto che l’inconscio (il sistema alla base delle condizioni psicologiche degli umani, e dei relativi comportamenti) ha e deve avere – secondo Lacan – la stessa struttura del linguaggio verbale. Questa tesi è sviluppata a partire dal 1955, e viene canonizzata nel libro XI dei Séminaires (1964, cfr. Lacan 1990). Sulla base di questo presupposto, Lacan prende esplicitamente di mira l’idea che si diano forme di comunicazione non verbale, connesse per esempio al “linguaggio del corpo”. E la sua critica poggia su tre presupposti principali (due almeno dei quali, all’apparenza, giustificati soltanto dalla necessità di auto-legittimare la propria professione): 1) tutti gli aspetti della comunicazione umana sono iscritti in strutture linguistiche (anche il “linguaggio del corpo”, ove mai si desse davvero); 2) scopo specifico del trattamento psicoanalitico è quello di articolare la verità dei desideri, quando questi siano espressi in forma verbale; e l’unico modo di far questo è attraverso la parola; 3) l’analista non ha altri metodi, se non quello della parola; pensare che ne esistano altri significa porsi fuori della psicanalisi (“Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse”, in Lacan, 1966, p. 237 sgg.). Giacché gli ultimi due argomenti hanno il carattere di mere petizioni di principio (che proiettano arbitrariamente sulla mente umana ciò che lo psicanalista si sente in grado di fare), possiamo limitarci soltanto alla prima: è davvero plausibile pensare che tutte le forme della comunicazione umana abbiano strutture analoghe a quelle del linguaggio?
Come abbiamo già ricordato, un presupposto del genere è revocato in dubbio dagli stessi padri fondatori della semiologia; e, più in generale, tutta la critica “post-strutturalista” si è adoperata nell’ultimo quarto del secolo scorso a demolire una presunzione del genere. Né riusciamo a credere, per restare al nostro tema, che gli esponenti più insigni del “teatro post-drammatico” abbiano in qualche modo finto (oppure sperato) di emanciparsi dal linguaggio, ma soltanto per mascherarlo, per ri-codificarlo sotto forma di immagini, atmosfere e rumori (se è vero, come Lacan pretende, che tutte le forme di comunicazione sono in definitiva linguistiche). Bisognerebbe mostrarlo, piuttosto che tenerci un sospetto del genere. E, viste le difficoltà che abbiamo già messo in luce nelle riflessioni di Roland Barthes, una dimostrazione del genere ci sembra molto complessa.
Scavare al di sotto dei simboli, intendersi
Su un altro versante della cultura contemporanea – quello delle scienze cognitive – il fatto che la mente non si limiti a processare simboli, ma investa una quota molto rilevante delle sue energie in attività di carattere sub-simbolico, non desta particolare scandalo, né preoccupazioni. Ammettendo che si diano attività sub-simboliche, e che queste siano di particolare rilievo, si postula implicitamente che la nozione stessa di “inconscio” è inadeguata, per spiegare molti aspetti della cognizione, del páthos e del comportamento umano: infatti, la nozione di inconscio è appunto legata all’idea che la mente umana sia una sorta di teatro, più o meno cosciente, nella quale si muovono soltanto delle entità che hanno che hanno la natura dei simboli, in senso proprio. Al contrario, per usare una felice metafora proposta da Daniel Dennett (Dennett, 1991), la stragrande maggioranza delle attività della mente si svolge al di sotto oppure dietro la scena del teatro, attraverso l’interazione di componenti che non hanno né la struttura degli omuncoli, né quella dei simboli, né quella dei connettivi e degli operatori logico-matematici. Tuttavia, questa estrema complessità della mente, questa plausibile dominanza dei livelli sub-simbolici, non ci impediscono di capirne qualcosa.
Torniamo dunque al nostro problema: c’è un modo di comprendere, o almeno di tematizzare, i modi specifici attraverso i quali l’azione teatrale produce effetti di tipo cognitivo, affettivo, comportamentale e performativo, in un’epoca nella quale le componenti para-teatrali del teatro acquistano maggiore rilevanza rispetto al passato (nei confronti del testo letterario)? Per discuterlo, dobbiamo precisare meglio il contenuto dell’espressione “componenti para-teatrali”. Di cosa stiamo parlando, in definitiva?
Se ci riferissimo al teatro tradizionale, queste componenti sarebbero le scene, i costumi, le luci, l’eventuale accompagnamento musicale, la posizione e i movimenti degli attori, i loro gesti, le loro espressioni, le loro voci, eccetera. Rispetto al testo, potremmo dire che questi sono gli elementi contestuali che accompagnano la sua enunciazione. Ora, nelle teorie correnti della comunicazione questi elementi non sono altro che le componenti pragmatiche del linguaggio. La pragmatica, come disciplina specifica che studia gli aspetti contestuali di ogni proferimento, si affianca alla sintassi e alla semantica, nello studio dei criteri che presiedono al successo della comunicazione. Appunto: oltre alla conoscenza della sintassi e della semantica (delle regole che riguardano i simboli), oltre al messaggio verbale, il successo della comunicazione mette capo al contesto, cioè al tempo ed al luogo, all’ambiente specifico, all’atmosfera, allo stato fisico, allo stato emotivo, alle credenze, alle conoscenze condivise, alle intenzioni, alla disponibilità a cooperare, alla mimica, ai modi particolari del proferimento, eccetera. Molti di questi elementi non hanno una struttura simbolica; tuttavia, noi siamo in grado di recepirli e di elaborarli; lo facciamo sicuramente, quando la comunicazione ha successo, modificando – se è il caso – il nostro stato cognitivo ed emotivo. Quando decifriamo il contenuto delle intenzioni comunicative di chi ci sta parlando (in quel particolare contesto), la comunicazione è appunto riuscita. E non è detto che le intenzioni del nostro interlocutore fossero puramente informative: potrebbe darsi il caso, come spesso succede, che le sue intenzioni riguardassero i nostri affetti, il nostro stato emotivo, i nostri comportamenti. In questo caso, il valore aggiunto della comunicazione, quanto al nostro patrimonio informativo di tipo verbale, potrebbe essere del tutto marginale, rispetto alla modifica indotta invece nelle nostre emozioni.
Supponiamo allora che tutte le componenti “contestuali” che abbiamo sopra indicato prendano il sopravvento, rispetto al messaggio verbale. In questo caso, se noi ci siamo recati comunque a un certo spettacolo (sperando di cavarne qualcosa), il meccanismo inferenziale che ci permette di norma di comunicare coi nostri simili rimarrà ancora attivo; dunque, noi continueremo a cogliere quelle componenti, a prescindere dal fatto che esse abbiano (o non abbiano) un carattere rigorosamente simbolico, dal fatto che abbiano (o non abbiano) un codice e un significato preciso.

Nell’ambito della teoria della comunicazione, meccanismi inferenziali di questo genere sono descritti ed analizzati nella “teoria della pertinenza” (Relevance Theory), proposta nel 1986 da Dan Sperber e dalla linguista britannica Deirdre Wilson (Sperber, Wilson, 1986). Si tratta di un paradigma che è stato applicato non soltanto ad alcune figure cruciali del parlare ordinario (come la metafora e l’ironia), ma anche alla poesia, alla letteratura, alla pittura e alla musica; dunque, non solo ai proferimenti verbali, ma anche ad altri tipi di stimolo. A partire da idee come queste:
Una caratteristica fondamentale della comunicazione umana, verbale e non verbale, consiste nell’espressione e nel riconoscimento di intenzioni […]. Obiettivo della pragmatica inferenziale [nel campo del linguaggio parlato] è quello di spiegare come l’ascoltatore inferisca il significato inteso dal parlante, sulla base dell’evidenza disponibile […]. Secondo la teoria della pertinenza, ogni stimolo esterno o ogni rappresentazione interna che costituisca l’input di un processo cognitivo può essere rilevante per un individuo, in qualche momento particolare […]. Intuitivamente, un input (un’immagine, un suono, un proferimento, un ricordo) è rilevante per un individuo quando si connette quando si connette con l’informazione di sfondo di cui egli dispone, per portarlo alla conclusione che gli interessa: per esempio, la risposta all’interrogativo che aveva in mente, l’incremento di conoscenza in un certo settore, risolvere un dubbio, confermare un sospetto, correggere una impressione sbagliata (Wilson, Sperber, 2004, pp. 607 – 608, trad. mia)
Però – malgrado sia abbastanza verosimile che il meccanismo inferenziale previsto dalla teoria della pertinenza sia applicabile in linea di principio (mutatis mutandis) a qualunque stimolo e a qualunque tipo di informazione (simbolica o non-simbolica che sia) – resta il fatto che le sue applicazioni finora più convincenti riguardano la comunicazione ordinaria, che rinvia in qualche modo al linguaggio verbale (anche quando è fatta di gesti, di ammiccamenti, di silenzi espressivi).
Allora, per porre un termine a questo lavoro (analizzando come la comunicazione possa funzionare, anche in ambiti in cui la parola e il verbo siano in linea di massima esclusi), rivolgiamo la nostra attenzione alla musica. Abbiamo infatti notato, quasi all’inizio di questo lavoro, che la musica (insieme alla danza, ai puri giochi di luce, eccetera) sembra occupare un estremo, nel ventaglio delle offerte teatrali contemporanee, che vanno da quelle in cui il testo letterario la fa ancora da padrone, a quelle in cui il testo è assente o marginale. La sfida è dunque: riusciamo a capire quale possa essere il valore cognitivo della musica, malgrado – almeno a detta dei semiologi – essa non abbia una struttura analoga a quella del linguaggio, non significhi nulla (se non, magari, se stessa) e sia, in questo senso “non intellegibile”?10 Per discutere quale sia il valore dell’esperienza musicale, sotto il profilo cognitivo, dobbiamo però accennare a una questione preliminare: quella, affrontata da tempi immemorabili, del rapporto tra ragione ed emozione. Visto che Barthes ci ha accompagnato per buona parte di questo lavoro, conviene partire ancora una volta da una sua annotazione, per introdurre il tema.
Dell’armonia di affetti
Ragionando sulla “polifonia informazionale” che la teatralità mette in scena (come intreccio mutevole tra il testo e le diverse componenti para-teatrali), Barthes si domandava se tutte le informazioni portate in scena (“disposte a contrappunto”) concorrano, oppure restino separate, nel conferire allo spettacolo un preciso senso unitario, oppure sensi diversi e incompiuti (Barthes, 2002, pp. 258-259). In particolare, per rispondere, Barthes si rivolge al lavoro di Brecht. La risposta è allora orientata all’apertura: malgrado quello di Brecht fosse un teatro dichiaratamente politico, si tratterebbe anche di un teatro che esibisce significanti non saturati (cioè sempre da decifrare, ancora e continuamente). Questa “apertura” – per Barthes – è legata soprattutto al fatto che il tempo storico messo in scena da Brecht è un tempo che non è ancora, perché l’emancipazione piena degli esseri umani è lungi dall’arrivare (Barthes, 2002, p. 261).

Su un piano più tecnico, questa apertura alla pluralità dei significati è legata invece al fatto che le componenti non testuali della teatralità (le componenti para-teatrali) sono “segni” in una accezione molto dubbia, perché non designano, oppure designano solo se stessi, oppure non sono riconducibili a una struttura linguistica verace (come abbiamo già segnalato). L’elemento in più, tuttavia, sta nel fatto che in questa “apertura”, malgrado la sostanziale indeterminazione del significato delle sue opere (a detta di Barthes!), Brecht sarebbe non di meno riuscito ad espungere in qualche modo (dall’ambito puramente conoscitivo del suo teatro) ogni tratto patetico. Leggiamo:
Brecht […] ha capito che il fatto teatrale poteva essere trattato in termini conoscitivi, e non in termini emotivi; ha accettato di pensare il teatro intellettualmente, abolendo la distinzione mitica (irrancidita ma ancora viva) fra la creazione e la riflessione, la natura e il sistema, lo spontaneo e il razionale, il “cuore” e il “cervello”; il suo teatro non è né patetico né cerebrale: è un teatro fondato (Barthes, 2002, p. 259)
Traspare in Barthes, da queste considerazioni, un atteggiamento convintamente anti-romantico, che non possiamo di certo deprecare. Però, paradossalmente, immaginare che il páthos possa (e debba) essere assorbito dal noûs, cioè dall’intelletto, significa pensare al primo come a qualcosa di pericoloso, per le facoltà del secondo. Dal 1739 almeno, cioè dalla data di pubblicazione di A Treatise of Human Nature, abbiamo ragione di credere – insieme a Hume – che le cose non stiano necessariamente così. Dobbiamo quindi riflettere meglio sul rapporto tra la cognizione e le affezioni, a quanto possiamo capirne a tutt’oggi, con tutta la scaltrezza che ormai ci è data.
Cosa dobbiamo intendere quando parliamo di “cognizione”? In un volume che è alla base della psicologia cognitivista contemporanea, Ulric Neisser scriveva nel 1967 che «il termine ‘cognizione’ si riferisce a qualsiasi processo nel quale […] un input sensoriale è trasformato, ridotto, elaborato, memorizzato, richiamato o usato» (Neisser, 1967, p. 4). D’altra parte, da una ventina di anni almeno, nella letteratura specialistica si parla anche di “stato affettivo nucleare” (o “stato affettivo di base”, letteralmente: “core affect”, cfr.: Russell, 2003), e questa condizione designa in genere uno stato psicologico primitivo, caratterizzato da due sole proprietà:
- valore edonistico (hedonic valence), articolato secondo un grado di piacere/dispiacere,
- eccitazione (arousal), articolata secondo un grado di attivazione/sonnolenza.
Quel che qui ci interessa è questo: il core affect funziona come una “core knowledge” (Spelke, 2000), ossia come un sistema cognitivo di base (nel senso di Neisser) che è presente fin dalla nascita, è tipico di tutti gli umani, rappresenta l’omologo di sistemi presenti anche in altre specie ed è rilevabile attraverso esperimenti controllati che abbiano come oggetto le emozioni (Barrett, 2006). Alla coscienza, il core affect si presenta attraverso le sensazioni del piacere o del dispiacere; oppure, con minore evidenza, come sensazione di attivismo o di stasi. Sotto il profilo fenomenologico, queste sensazioni appaiono alla coscienza come separate e distinte rispetto a quelle legate al pensiero e alla memoria; tuttavia, i sistemi cerebrali distribuiti che presiedono alla gestione del sistema degli affetti sono strettamente legati a quelli che deputati alla cognizione; anzi, ne rappresentano il nucleo di base. Proprio in virtù di queste connessioni, il core affect gioca, praticamente, un ruolo cruciale in tutti i processi cognitivi. In particolare, si è ormai accumulata una sufficiente evidenza che porta a giudicare inconsistente la tradizionale distinzione tra le aree corticali del cervello (riservate alle funzioni più elevate ed evolute) e quelle sub-corticali (riservate invece a quelle meno nobili e primitive). Oggi sappiamo piuttosto che le regioni tradizionalmente considerate cognitive partecipano nel determinare stati affettivi (non solo per regolarli); d’altra parte, sappiamo che molte regioni del cervello tradizionalmente considerate affettive sono implicate in processi cognitivi. Quindi, malgrado una lunga tradizione induca a pensare il contrario, se ci atteniamo alla definizione di Neisser dobbiamo necessariamente concludere che le affezioni sono una forma della cognizione (Duncan, Barrett, 2007; Pessoa, 2008). Una conclusione importante, ancora non colta – e vista anzi come una dicotomia mutuamente esclusiva, come quasi un ossimoro – da molti studiosi di teatro11.
Tenendo tutto questo in mente, arriviamo al punto finale: cosa possiamo dire, sugli effetti cognitivi, affettivi, comportamentali e performativi che la musica induce, malgrado non si tratti (come abbiamo ricordato) di una struttura di tipo linguistico?
Osserviamo preliminarmente che la “soluzione” semiologica – che riferisce il “campo di significanza” della musica a posizioni, a tensioni e a movimenti del corpo – è poco plausibile e molto insoddisfacente: se è indubbio che la musica produca – tra le altre cose – effetti cinestesici, pretendere che soltanto questa sia la sua valenza cognitiva (nel senso che abbiamo appena specificato) è riduttivo. Noi non temiamo gli affetti, non abbiamo alcuna paura delle emozioni; quindi, siamo pronti ad ammetterli nel “campo di significanza” della musica, insieme agli aspetti comportamentali.
Ciò detto: quando ci interroghiamo sugli “effetti cognitivi della musica”, cosa davvero cerchiamo? Visto che parliamo di “effetti”, sembra quasi scontato immaginare che andiamo cercando qualche tipo di meccanismo; una “macchina”, o un processo inferenziale, che – nelle diverse e possibili occorrenze di un’esposizione a brani musicali – produca nei soggetti interessati effetti cognitivi rilevabili; oppure, per converso, che a partire da certi contesti, da certe conoscenze di sfondo e da certe intenzioni, questa “macchina” conduca alla produzione di certi brani musicali. Perché questo “meccanismo” (o processo mentale) abbia una funzione non aleatoria, bisognerebbe che tra le diverse tipologie di stimoli e le diverse tipologie di risultati ci fosse qualche tipo stabile di correlazione; che cioè – per esempio – brani musicali riconducibili a una stessa “famiglia” riescano a provocare analoghi effetti cognitivi; e che, per converso, certe condizioni cognitive di partenza, tra loro assimilabili per qualche classe di caratteristiche specifiche, conducano a produzioni musicali in qualche modo assimilabili (per qualche tratto oggettivo). È ovvio in ogni caso, almeno agli occhi di chi scrive, che la quantità delle variabili in gioco e la complessità delle loro relazioni può fare forse sperare – nel caso più favorevole – che per gli input e gli output di questa eventuale “macchina” mentale si rilevino soltanto correlazioni tra cluster abbastanza liquidi e sfumati12.
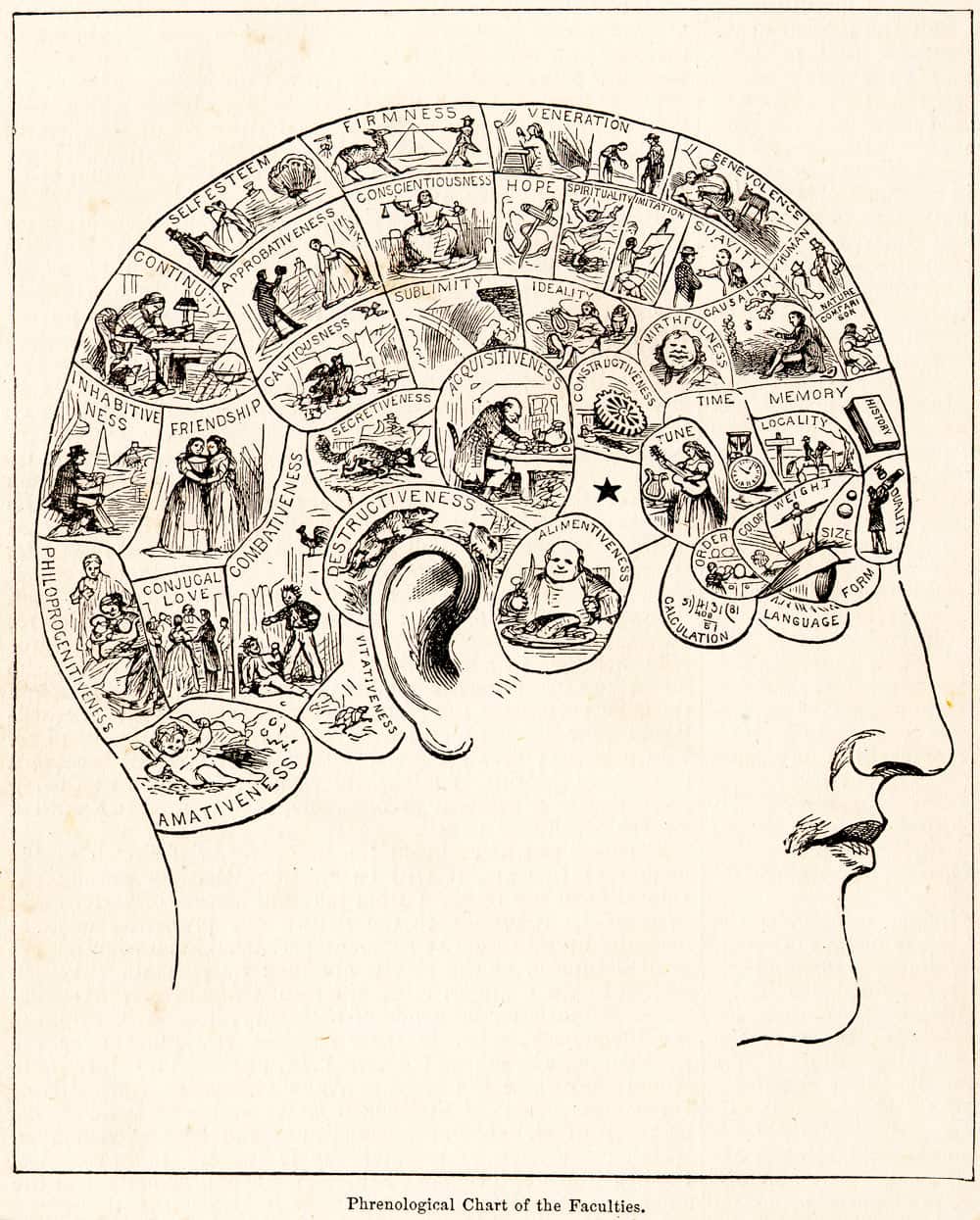
Ciò detto, cosa sappiamo in merito? Per una rassegna molto sintetica sulla questione, affidiamoci al parere di John Sloboda e Patrik Juslin, che studiano da almeno un quarto di secolo proprio questo problema. Visto che il nostro obiettivo è soltanto quello di suggerire un punto di vista (quello delle scienze cognitive) e di perorare una prospettiva (la costruzione di una griglia di strumenti e concetti che ci aiutino nell’analisi del teatro contemporaneo), non discutiamo in dettaglio la stabilità, la consistenza e l’attendibilità di questi risultati. Ci limitiamo ad affermare che discuterli, entrando nel merito, già significa accettare una prospettiva, un metodo di lavoro e un ambito di riflessione.
Dunque, secondo (Sloboda, Juslin, 2010, pp. 73-97):
- le connotazioni emotive di molti stimoli musicali sono consistenti e prevedibili;
- la musica non si limita ad esprimere emozioni che possono essere riconosciute dagli ascoltatori, ma è anche in grado di evocare emozioni;
- le emozioni evocate dalla musica implicano in genere risposte sincronizzate, a parecchi livelli dell’organismo;
- le risposte emotive agli stimoli musicali dipendono in maniera apprezzabile dalle relazioni che sussistono tra lo stimolo, chi ascolta e il contesto della stimolazione;
- la risposta a stimoli musicali in grado di evocare emozioni “positive” è più rapida, diretta e frequente, rispetto a quella provocata da stimoli che evocano emozioni “negative” (ovviamente, tutto questo presuppone che sia possibile una tassonomia delle emozioni; la cosa può essere mostrata, ma dobbiamo darla qui per scontata);
- le emozioni musicali sono plausibilmente evocate grazie all’attivazione di diversi meccanismi, ognuno dei quali è specializzato nel trattamento di particolari tipi di informazione;
- le emozioni musicali dipendono in modo significativo dalle condizioni, dagli obiettivi e dalle disposizioni degli ascoltatori.
Tutto qua? Si potrebbe restare delusi. Di certo, ammesso che siano verosimili, risultati del genere non delineano una teoria. Però, se ritorniamo alle indicazioni molto scarse della Poetica e della Retorica aristotelica – che si limitavano in fin dei conti a raccomandare un’appropriata concatenazione dei fatti, nell’enunciazione drammatica – allora possiamo concludere che non siamo messi poi così male.
Infatti, noi ci siamo esposti soltanto nel sostenere che comprendere il rapporto con il teatro significa comprendere come funziona la comunicazione, in questo ambito specifico; e nell’aggiungere che – alla fine del secondo millennio – disponiamo di buone teorie della comunicazione, le quali descrivono modelli inferenziali condivisi, a partire da stimoli, conoscenze di sfondo, elementi contestuali e intenzioni. Se dunque, anche in un campo così sfuggente come quello del “significato” della musica noi riusciamo a capire qualcosa delle reazioni agli stimoli e del loro effetto sulle emozioni, allora la strada intrapresa sembra interessante e prolifica.
Bibliografia
Aristotele, 1961, Retorica, trad. it. a cura di A. Plebe, Laterza, Bari.
Barrett L.F., 2006, “Solving the emotion paradox: Categorization and the experience of emotion”, Personality and Social Psychology Review, 10, pp. 20-46.
Barthes R., 1964, “Éléments de sémiologie”, Communications, 4, pp. 91-135.
Barthes R., 2001, L’ovvio e l’ottuso. Saggi critici III, Einaudi, Torino (ed. orig. 1982, L’obvie et l’obtus. Essais critiques III, Seuil, Paris).
Barthes R., 2002, Saggi critici, Einaudi, Torino (ed. orig. 1964, Essais critiques, Seuil, Paris).
Blair R., Cook A. (a cura di), 2016, Theatre, Performance and Cognition, Bloomsbury, London.
Cavarero A., 2003, A più voci. Filosofia dell’espressione vocale, Feltrinelli, Milano.
De Marinis M., 2008, Capire il teatro. Lineamenti di una nuova teatralogia, Bulzoni, Roma.
Dennett D., 1991, Consciousness Explained, The Penguin Press, New York.
Duncan S., Barrett L.F., 2007 “Affect is a form of cognition: a Neurobiological analysis”, Cognition and Emotion, 21, pp. 1184-1211.
Falletti C., Sofia G., Jacono V., 2016, Theatre and Cognitive Neuroscience, Bloomsbury, London.
Finter H., 2014, Le corps de l’audible. Écrits fraçais sur la voix 1979-2012, Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main.
Fisher-Lichte E., 2016, Estetica del performativo. Una teoria del teatro e dell’arte, Carocci, Roma (ed. orig. 2004, Ästhetik des Performativen, Suhrkamp, Frankfurt am Main).
Frege G., 1884, Die Grundlagen der Arithmetik: eine logisch-mathematische Untersuchung über den Begriff der Zahl, Koebner, Breslau.
Gadamer H.G., 1986, L’attualità del bello. Saggi di estetica ermeneutica, Marietti, Casale Monferrato (ed. orig. 1997, Die Actualität des Schönen: Kunst als Spiel, Symbol und Fest, Philipp Reclam, Stuttgart.
Kristeva J., 1974, La révolution du langage poétique, Seuil, Paris.
Kuhn T.S., 1962, The Structure of Scientific Revolutions, Chicago Un. Press, Chicago.
Jackendoff R., 2009, “Parallels and Nonparallels between Language and Music”, Music Perception, 22, pp. 195-204.
Jackendoff R., Lerdahl F., 2006, “The capacity for music: What is it, and what’s special about it?”, Cognition, 100, pp. 33-72.
Lacan J., 1953, “Some reflections on the ego”, International Journal of Psychoanalysis, 34, pp. 11-17.
Lacan J., 1966, Écrits, Seuil, Paris.
Lacan J., 1990, Le Séminaire, tome 11 : Les Quatre Concepts fondamentaux de la psychanalyse, 1964, Seuil, Paris.
Lehmann H.-T., 1999, Postdramatisches Theater, Verlag der Autoren, Frankfurt am Main, ed. ingl. 2006, Postdramatic Theatre, Routledge, London – New York.
Lerdahl F., Jackendoff R., 1983, A generative theory of tonal music, MIT Press, Cambridge MA.
McConachie, Blair R. (a cura di), 2013, Affective Performance and Cognition Science, Bloomsbury, London.
Neisser U., 1967, Cognitive psychology, Prentice-Hall, Englewood Cliffs NJ.
Pavis P., 2004, L’analisi degli spettacoli. Teatro, mimo, danza, teatro-danza, cinema, Lindau, Torino (ed. orig. 1996, L’analyse des spectacles. Théâtre, mime, danse, cinéma, Nathan, Paris).
Pessoa L., 2008, “On the relationship between emotion and Cognition”, Nature Review | Neuroscience, 9, pp. 148-158.
Plassard D., 2012, “O pós-dramático, ou seja, a abstação”, Sinais de cena, 18 b, 3, pp. 14-20.
Russell J.A., 2003, “Core affect and the psychological construction of emotion”, Journal of Personality and Social Psychology, 110, pp. 145-172.
Sarrazac j.-P. (a cura di), 2005, Lexique du drame moderne et contemporain, Circé, Belval.
Sarrazac J.-P., Naugrette C. (a cura di), 2007, La réinvention du drame (sous l’influence de la scène), Études Théâtrales, Louvain.
Schechner R., 1994, Environmental Theater, Applause, New York.
Sloboda J., Juslin P., 2010, “At the interface between the inner and the outer world. Psychological perspectives”, in Juslin P., Sloboda J., (eds.), Handbook of Music and Emotions, Oxford Un. Press, New York.
Spelke E.S., 2000, “Core knowledge”, American Psychologist, 55, pp. 233-243.
Sperber D., 1974, Le Symbolisme en général, Hermann, Paris; ed. ingl. 1975, Rethinking Symbolism, Cambridge University Press, Cambridge UK.
Sperber D, Wilson D., 1986, Relevance. Communication and Cognition, Blackwell, Cambridge MA.
Szondi P, 1962, Teoria del dramma moderno (1880-1950), Einaudi, Torino (ed. orig. 1956, Theorie des modernen Dramas. Suhrkamp, Frankfurt am Main.
Valentina V., 2007, Mondi, corpi, materie: teatri del secondo Novecento, Bruno Mondadori, Bruno Mondadori, Milano.
Valentini V. (a cura di), 2012, Drammaturgie sonore. Teatri del secondo Novecento, Bulzoni, Roma.
Valentina V., 2016, Nuovo teatro made in Italy (1963-2013), Bulzoni, Roma.
Wilson D., Sperber D., 2004, “Relevance Theory”, in Horn L., Ward G. (eds.), The Handbook of Pragmatics, Blackwell, New York, pp. 607-632.
- Hans Gadamer, riferendosi alla pittura astratta, le attribuiva un “linguaggio ammutolito”; ammetteva però che quelle forme e quei colori, privati di ogni riferimento, continuano a risuonare in noi, come «una specie di musica oculare» (Gadamer, 1986, p. 138). Valentina Valentini (riflettendo sullo sganciamento della pura vocalità dal linguaggio verbale, tipico di molto teatro del secondo Novecento) commentava che «l’ammutolire della parola […] potrebbe anche non significare, non avere nulla da dire» e, ciononostante, «l’indistinto, il corporeo, il balbettio potrebbero […] annunciare l’approssimarsi di un linguaggio rinvigorito dall’attraversamento corporeo, una parola carica di valori musicali, ritmici, sensoriali, che sia riconoscibile e portatrice dell’esperienza interiore» (Valentini, 2012, p. 31; vedi anche Valentini, 2007, pp. 51-52). ↩
- Valga per tutti, come esempio di questo disinteresse per l’approccio cognitivo, la parte terza (“Le condizioni della ricezione”) della minuziosa analisi degli spettacoli di Patrice Pavis (Pavis, 2004): tra la modalità di trattamento delle informazioni che gli spettatori possono raccogliere nel corso di uno spettacolo, Pavis elenca l’approccio psicologico/psicoanalitico, quello sociologico, quello antropologico. Nessun riferimento alla pragmatica, ai risultati del cognitivismo e della psicologia evoluzionistica contemporanea. Diversa è in parte la situazione nel mondo anglosassone; basterà qui citare (McConachie, Blair, 2014) e (Blair, Cook, 2016). Più orientato ad analizzare le connessioni con le neuroscienze è (Falletti, Sofia, Jacono, 2016), risultato dei “Dialogues between Theatre and Neuroscience”, avviati nel 2009 nell’Università Sapienza di Roma. Già nel 1985 Marco De Marinis segnalava del resto «resistenze piuttosto forti» negli studi sul teatro, rispetto all’approccio cognitivista; e riferiva queste resistenze a una diffusa opposizione ai modelli generali (d’impianto scientifico, o genericamente “razionalistico”), nelle analisi dei «processi ricettivi dello spettatore del teatro» (De Marinis, 2008, pp. 354-355). ↩
- «L’ipotesi che proponiamo è che una parte significativa del teatro del nuovo millennio declini le sue “drammaturgie dei corpi diffuse”, senza alcuna gerarchia tra organico e inorganico, tra reale e virtuale» (Valentini, 2016, p. 131). ↩
- Cfr., per esempio, (Sarrazac, Naugrette, 2007, pp. 16-17). ↩
- Adriana Cavarero ha contestato la priorità astratta del lògos, rispetto alla vocalità che lo esprime. Nella prima parte di un saggio del 2003 – intitolato appunto “Come il lògos perse la voce” – Cavarero ha ricordato che in Aristotele il lògos è phonè semantichè, laddove l’accento è posto proprio sull’aspetto semantico dell’espressione sonora, che fa della voce umana qualcosa di ontologicamente diverso dal grugnito animale. Ma la voce, per Cavarero, è un tratto di identità, di unicità, è un veicolo molto potente di affetti e intenzioni; si tratterebbe dunque di ribaltare la priorità del pensiero, rispetto alla parola; e questo avviene, infatti, nella voce dell’arte: «c’è un campo della parola dove la sovranità del linguaggio si arrende a quella della voce. Si tratta, ovviamente, della poesia» (Cavarero, 2003, p, 16). Nel propugnare un punto di vista che riconosca il carattere unico e individuale della voce, Cavarero prende le distanze da quelle teorie che – pur riconoscendo l’importanza della grana vocale, come snodo essenziale tra il corpo e il discorso (Barthes) – trascurano l’aspetto della singolarità della voce, cioè la centralità dell’individuo (e, semmai, del genere). Più che dalla messa in questione della priorità del contenuto concettuale della comunicazione (rispetto alle modalità del proferimento), l’interesse di Cavarero è mosso dunque da una istanza politica: utilizzando la voce/parola, gli esseri umani non avrebbero inventato un mezzo potentissimo per cooperare tra loro; piuttosto, attraverso la voce/suono, a ogni individuo sarebbe concesso di comunicare al mondo la propria unicità. Una tesi – questa – orientata a sorreggere una ontologia delle differenze, che in nulla ci aiuta rispetto al problema che ci siamo qui posti: che ruolo hanno, nella comprensione di uno spettacolo, i suoi aspetti “para-teatrali”, come l’emissione di suoni e rumori, che prescindono da un testo. ↩
- Richard Schechner lo ha teorizzato in modo esplicito, nel sesto dei suoi “assiomi”, per l’Environmental Theater: «Il testo non deve essere né il punto di partenza né quello di arrivo di una produzione. Il testo può mancare del tutto» (Schechner, 1994, p. xli). ↩
- Scrive a questo proposito Valentina Valentini: «Nella Tragedia Endogonidia avviene una dislocazione della forma tragica dal piano semantico a quello delle materie espressive: al suono è affidato il compito di esprimere il pathos degli eventi, come lo sconquasso tellurico e i fremiti scomposti e incontrollabili di corpi colpiti da epilessia. Il suono è l’elemento che crea tensione, brivido, disturbo insopportabile. Sull’altro versante, la trama del silenzio: la tragedia dell’ammutolimento e del solipsismo. Fondare una mitologia contemporanea per la Socìetas Raffaello Sanzio ha significato costruire una scena smaterializzata, fatta di luce, suono, silenzio, canto, ma privata della parola. La maggior parte delle dramatis personae sono dotate di movimento, anche questo economizzato, ma non di parola: la scelta di non comunicare intelligibilmente marca la tragedia» (Valentini, 2016, p. 128). ↩
- Sulle obiezioni a Lehmann, si vedano per esempio: J.-P. Sarrazac, “La reprise”, in (Sarrazac, 2007, pp. 7- 18) e (Plassard, 2012), tradotto per questo numero di Sciami|Ricerche. ↩
- «Un continuum di eventi teatrali mescola una forma con l’altra: gli eventi pubblici e le manifestazioni (cioè l’impuro, la vita) ¬® l’intermedio e l’happening ¬® l’environmental theater ¬® il teatro ortodosso (cioè il puro, l’arte)» (Schechner 1994, p. xix). ↩
- In verità, dobbiamo riconoscere che la cosa si presenta oggi in modo più complicato, rispetto a come la presentava Barthes negli anni Settanta del secolo scorso. Senza poterla commentare (per ovvie ragioni di spazio e di merito), bisogna almeno ricordare che nel 1983 Fred Lerdahl e Ray Jackendoff hanno proposto una “teoria generativa della musica tonale” (GTTM), che pretendeva di dare conto delle competenze umane nel campo della musica (all’apparenza innate), in maniera analoga alla grammatica generativa di Chomsky (Lerdahl, Jackendoff, 1983)). Anche in tempi a noi più vicini, Jackendoff e Lerdhall sono tornati a confrontare le caratteristiche del linguaggio ordinario con quelle della musica (Jackendoff, 2009) e ad analizzare la natura delle capacità musicali (Jackendoff , Lerdahl, 2006). ↩
- Per esempio, abbiamo già richiamato nelle premesse quale sia l’opinione di Erica Fisher-Lichte, a questo proposito. Ma notava nel 1985 Marco De Marinis: «È del tutto impossibile e fuorviante separare in maniera dicotomica gli aspetti emotivi e gli aspetti cognitivi della esperienza teatrale o, peggio ancora, contrapporre gli uni agli altri. L’esperienza teatrale, in quanto esperienza estetica, va concepita […] come un insieme complesso di processi percettivi, interpretativi, emotivi, valutativi e mnemonici, che interferiscono e interagiscono tra loro» (De Marinis, 2008, p. 357). ↩
- Però forse, non è nemmeno il caso di disperare. A parte i risultati cui riferiremo tra poco, viene sempre in mente il caso di David Cope, l’autore californiano che a partire dai primi anni Novanta del secolo scorso ha messo a punto programmi e algoritmi che sono in grado di analizzare brani di musica originali e ricreare composizioni nello stesso stile di quelle analizzate; se questo è il caso, possiamo non disperare, quanto alla individuazione di caratteristiche implicite della musica, rilevabili in modo quasi automatico. Per analogia, nel campo letterario, viene in mente lo strano caso di Phil M. Parker, che ha brevettato nel 2007 un procedimento che gli permette di realizzare una collezione potenzialmente illimitata di libri, grazie a un modello che viene riempito automaticamente, a partire da brani prelevati da un database e da ricerche in rete. Nel 2008, Parker si attribuiva la “creazione” di oltre 200.000 volumi; ad oggi, una ricerca di questo autore sui libri venduti da Amazon produce circa 103.000 risultati. ↩
